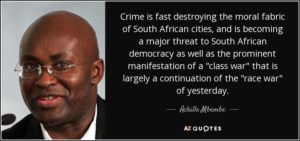Il valore dell’estetica africana
di Achille Mbembe
Ho scritto On the Postcolony (Postcolonialismo, Meltemi, Roma 2005) principalmente di notte. Era l’inizio degli anni ’90, quando l’ombra cupa dell’Afro-Marxismo cominciava a dileguarsi. Sembrava, a quel punto, che gli studi sull’Africa dovessero rimanere intrappolati in un drammatico stallo analitico. Erano molti gli studiosi che mettevano in circolazione mappe del presente sempre più inutili, proprio nel momento in cui nuovi drammi si stavano profilando.
Mentre la crisi delle scienze sociali si aggravava, in campi disparati come il design, la narrativa, la moda, la pittura, la danza e nell’ambito dell’estetica in generale emergevano tendenze innovative, persino un nuovo modo di pensare. In tutte quelle discipline fondate sull’immaginazione si andava sviluppando una sorta di riconciliazione tra la cosiddetta identità africana e una certa idea di mondanità, se non proprio di cosmopolitismo.
Ma una biografia di On the Postcolony non sarebbe completa senza un riferimento diretto alla musica africana. Ho scoperto la musica congolese alla fine degli anni ’80; epoca di programmi di aggiustamento strutturale, guerre predatorie, crudeltà e stupidità presentate come capacità di governare, colpi di stato militari e rivoluzioni sociali continuamente rinviate. La sublime emotività dell’immaginazione musicale congolese mi ha insegnato quanto fosse indispensabile pensare attraverso la fisicità dei sensi, scrivere attraverso la musicalità della propria carne.
Attraverso questa musica non solo potevo sentire muoversi l’energia, potevo anche cogliere la verità del monito di W.E.B. du Bois: “La vita non sono semplicemente i fatti”. La musica ha la capacità di coniugare l’anima e la materia. E davvero in Africa la musica è stata sempre la celebrazione dell’impossibilità di sradicare la vita, all’interno di una lunga storia di negazione della vita. È il genere che storicamente ha espresso, nella maniera più tenace, il nostro furioso desiderio non solo di esistere, ma di provare gioia nell’esistere: quello che potremmo chiamare l’esercizio, la pratica della gioia prima della morte.
Il romanzo africano è l’altro elemento biografico diretto di questo libro. Dai tardi anni ’80 in poi la migliore narrativa africana celebrava già la fine del progetto nazionalista e delle pretese dei governanti africani post coloniali di assumere il ruolo del Padre. Allo stesso tempo, il romanzo ci avvertiva dell’emergere di forze nuove, insolite, che non potevamo del tutto cogliere né comprendere attraverso i linguaggi concettuali dominanti di allora (sviluppo, relazioni tra stato e società, società civile).
Ho iniziato a leggere l’opera dello scrittore congolese Sony Labou Tansi alla fine degli anni ’80. In La Vie et demie, L’État honteux, Les Sept solitudes de Lorsa Lopez o La Parenthèse de sang, la sperimentazione veniva sempre prima dell’ontologia. Si costruivano ponti inaspettati tra astrazione e concretezza, ragione, emozione e affettività, coscienza, inconscio e onirico. Arte e pensiero prendevano vita e risuonavano l’uno nell’altra.
L’idea di Tansi di un accordo costantemente rinviato per permettere di introdurre nuove domande nel discorso rivelava il bisogno di espandere il dizionario per dare spazio a un ripensare, un reinventare: per permettere alla differenza di diventare produttiva. La contingenza, l’incertezza e l’effimero sembravano offrire un vasto serbatoio di libertà e improvvisazione creativa (free play). Ho trovato la stessa abilità nel cogliere l’intangibile in L’ivrogne dans la brousse di Amos Tutuola (Il bevitore di vino di palma, Feltrinelli, Milano 1961, orig. The Palme-wine Drinkard) e in Le Devoir de violence di Yambo Ouologuem (Dovere di violenza, il Saggiatore, Milano 1970).
Fu a quel punto che decisi di scrivere un libro in cui dare spazio alle risonanze e alle interferenze tra modi diversi di pensare senza che uno di questi prevalesse sugli altri. Il modo migliore per farlo era chiedersi quale forma avrebbe potuto assumere una critica politica ed estetica del Padre nell’Africa dell’ultimo quarto del XX secolo e come, a causa delle sue potenti risonanze – e, mi auguravo, della sua unicità esplicativa – una critica del Padre (la “cosa” e i suoi doppi) ci avrebbe permesso di scrivere una storia alternativa del nostro presente.
Di On the Postcolony si può dire, perciò, che è il tentativo di svelare che cosa si nasconda dietro la maschera del Padre. Quale forma assume il Padre dopo la fine del colonialismo in senso stretto? Che aspetto ha il suo viso? Quali sono i suoi contorni? Che cosa viene messo in scena per mezzo del Padre, e a quali apparenze dà luogo?
Parafrasando Deleuze, quel che avevo trovato era una specie di “culo del capro espiatorio” che viveva “colpito da maledizione” (Millepiani, Castelvecchi, Roma 1997, p. 191) e stava di fronte alla faccia del dio pagano, morte occultata nell’oscurità ma anche oscurità manifesta e maleodorante nella piena luce del giorno. On the Postcolony guarda dunque in quali maniere questo Fallo che ha le sembianze di un culo di capro rappresenta se stesso e come si rifrange nella coscienza di coloro che vivono sotto il suo incantesimo. Ossia, in breve, qual è il significato della vita vissuta sotto il suo segno e come risultato del suo potere (de)generativo.
Questo modo di pensare e di scrivere deriva in gran parte dai miei studi specifici sulla tradizione intellettuale francese del secondo dopoguerra (rappresentata, per esempio, da Bataille, Merleau-Ponty, Foucault, Blanchot, Deleuze). Ma, come ho già detto, si radica anche nella lettura del romanzo francofono africano e nell’ascolto della musica africana della fine del XX secolo.
Entrambe queste tradizioni mi hanno insegnato che pensare è sperimentare. Pensare è anche recuperare e salvare il potere figurativo dell’allegoria applicata ai domini specifici dell’esperienza umana, dei quali è la forma di espressione adeguata, o il linguaggio concettuale, che serve a esprimere questa esperienza soltanto. Pensare, infine, è imbarcarsi in un viaggio della mente, e scrivere è una forma di godimento. È per questo che in On the Postcolony volevo sperimentare la sensazione che si produce quando la mente è disposta a lasciar andare le cose in direzioni imprevedibili, correndo il rischio di trovarsi faccia a faccia con desideri e paure inesprimibili e di risvegliare le forze soprannaturali dei nostri inferi.
Questa è forse la ragione per cui chi ha letto On the Postcolony senza una disposizione d’animo filosofica lo ha definito pessimistico. Vengo da una tradizione nella quale “pensare” (penser) equivale a “pesare” (peser) e a “esporre”. Pensare criticamente significa lavorare sulle linee di confine tra opposti, percepire il tocco caotico dei nostri sensi, trasferire nel linguaggio le logiche costitutive del nostro mondo.
La critica è testimonianza, ma è anche un vigilare, un interrogarsi e un anticipare senza fine. Una critica seria ci richiede innanzitutto di dimorare nel caos della notte, precisamente allo scopo di aprirci meglio un varco nella luce abbagliante del giorno.
Riconosciamo un momento di pessimismo quando gli strati del passato e il mondo del presente cadono nel vuoto; si tratta di questo, un luogo che non è un luogo. Riconosciamo un momento di pessimismo quando banalizziamo l’esperienza umana o suscitiamo un’empatia o un disprezzo mal riposti, quando, incapaci di liberare il linguaggio, soccombiamo alla semplice materialità dell’esistente.
Entriamo in una “oscura notte del linguaggio” quando il suo potere di esprimere simbolicamente all’improvviso viene menomato, e invece di rivelare quel che si nasconde nell’ovvietà e quel che giace sotto la superficie, oltre la maschera, il linguaggio gira su se stesso nascondendo ciò che dovrebbe mostrare.
Dall’arte, la letteratura, la musica e la danza ho imparato che esiste un’esperienza sensoriale delle nostre vite che comprende forme, tinte e trame innumerevoli, innominate e innominabili, di cui la “conoscenza oggettiva” non è riuscita ad appropriarsi. Il linguaggio di queste forme di espressione comunica il modo in cui le persone comuni ridono e piangono, lavorano, giocano, pregano, benedicono, amano e maledicono, creano uno spazio in cui esistere e camminare, cadere e morire.
La letteratura, e la musica in particolare, sono anche pratiche di dissacrazione e profanazione. Ognuna a suo modo implica un gioco paradossale e a volte rischioso con i limiti – quelli determinati dall’ordine politico o morale e quelli che modellano il linguaggio e lo stile, il pensiero e il significato.
La forza quieta delle pratiche artistiche africane va cercata nel modo in cui vedono ogni momento o istante dell’esistenza umana come interamente fortuiti e allo stesso tempo assolutamente singolari. Nella migliore tradizione dell’arte, la musica e la letteratura africane, ogni momento dell’esistenza umana è fatto di punti di intensità che non sono mai stabili. In On the Postcolony non c’è nulla che assomigli a una storia lineare. L’Africa non sarà mai un dato.
Ma affrontare il passato e interrogare il futuro ci aiuta a riflettere criticamente sul presente. Il presente inteso come questo spazio vulnerabile, questo punto d’accesso precario ed elusivo attraverso il quale, se tutto va bene, una vita radicalmente differente potrebbe fare la sua comparsa. Non c’è futuro senza speranza: la speranza che potremo convertire questa vita terrena radicalmente differente in una possibilità sociale concreta, una trasformazione sistemica nella logica del nostro essere-in-comune e essere-nel-mondo come esseri umani.
(traduzione di Caterina Grimaldi)