Tre motivi per chiedere le dimissioni della ministra Azzolina
Una richiesta di Francesco Masala
e testi di Amedeo Spagnuolo, Renata Puleo, Anna Angelucci, Franco Lorenzoni, Giovanni Carosotti, Girolamo De Michele, Lorenzo Asti, Marco Meotto, Maria Chiara Pievatolo, Rossella Latempa, Priorità alla Scuola, Rete Bessa e la lettera di una lavoratrice bolognese nell’ambito dell’educazione (i siti da cui sono ripresi sono in calce a ogni articolo)
Cattivo gusto
Azzolina agli studenti che avrebbero dato l’esame di stato ha detto: “Siete nella storia”.
Lo stesso cattivo gusto di chi avesse detto ai superstiti del Titanic: “Siete nella storia”.
Incapacità e/o ignoranza (che non è mai scusabile, a quei livelli)
Ignorare l’esistenza del GARR (“GARR è la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca. Il suo principale obiettivo è quello di fornire connettività ad alte prestazioni e di sviluppare servizi innovativi per le attività quotidiane di docenti, ricercatori e studenti e per la collaborazione a livello internazionale. La rete GARR è ideata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” – da qui) è gravissimo.
E se, come pare, la dad continuerà anche nel prossimo anno scolastico useremo Google o GARR?
Come se il ministro della Sanità ignorasse l’esistenza di un vaccino creato e brevettato da un’università pubblica italiana e allo stesso tempo comprasse milioni di dosi dello stesso vaccino da una multinazionale svizzera della Vaccin Valley.
Quel ministro della Sanità sarebbe rimosso entro 24 ore.
Irresponsabilità
Aver detto che nessuno avrebbe perso l’anno scolastico quando le scuole erano state appena chiuse è come se il direttore di un ipermercato avesse detto più e più volte, attraverso la stampa, e all’interno dell’esercizio commerciale, che i dispositivi antitaccheggio e le telecamere di sorveglianza sarebbero state fuori uso per i successivi tre mesi.
Quel direttore sarebbe stato rimosso il giorno dopo.
E una domanda alla ministra
Il nuovo Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell’Istruzione Marco Bruschi (qui) è lo stesso Max Bruschi, massone, di cui riferisce Perla Genovesi, pentita di un traffico di droga, in un’intervista di Giovanni Bianconi, sul Corriere della Sera, il 12 novembre del 2010 (qui)?
SI RIPARTE DAL VIA – Priorità alla scuola
Noi manifestiamo NON SOLO PER ma anche CONTRO
A un mese dalle “indiscrezioni” della dottoressa Ferrario sulle conclusioni del CTS, ecco che circola la bozza del documento ministeriale che dovrebbe uscire dalle consultazioni del 25 giugno. Vogliono verificare la nostra reazione? È la stessa di un mese fa.
Le nostre manifestazioni del 25 giugno diventano sempre più PER la riapertura della scuola e CONTRO le linee guida.
Il ministero dice che rispetterà le “indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile”.
E ripropone tutto quello contro cui lottiamo da fine aprile:
– turni per tutti;
– didattica ibrida (DAD e presenza) per tutti gli studenti delle superiori;
– esternalizzazioni (tutto lavoro precario) per completare il tempo scuola, sdoganato definitivamente il ruolo dei privati nelle scuole
– classi spezzettate in gruppi, pomposamente chiamati “gruppi di apprendimento”;
– “moduli” di alunni, composti non si sa come “dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso” (sarà mica che ci ritroviamo con quelle che una volta si chiamavano con la infelice espressione di “classi differenziali”, o peggio ancora?);
– insegnamenti “trasversali” per accorpare materie e risparmiare un po’ di ore di scuola;
– a scuola il sabato, ma per completare quale orario? Non si sa.
Il documento si distingue per la prosa ministerialese e scuolese, e inventa il gioco perfetto che permette di non finanziare decentemente la scuola pubblica. Né una persona né un soldo in più, ogni scuola faccia da sé, con i mezzi propri e quel che offrono i territori e gli Enti locali.
In nome dell’autonomia scolastica, che viene comoda quando il governo non si vuole assumere responsabilità, viene delegato totalmente alle singole scuole come “riaprire le scuole a settembre”.
Tutto dipenderà dalle scelte, e dalle possibilità, delle singole scuole, senza che siano indicate né condizioni minime né risorse aggiuntive disponibili, con buona pace del diritto allo studio dei bambini e ragazzi.
L’intero documento sottende una visione non unitaria del paese. Secondo questa visione sarà sempre più difficile parlare di una scuola pubblica nazionale!
I dirigenti scolastici saranno alla guida dei “loro” plessi, la formazione dei docenti sarà incentrata sulle competenze digitali “[…]per non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai docenti nel periodo di sospensione delle attività in presenza”
Sul punto degli interventi di edilizia scolastica per l’adattamento degli spazi interni ed esterni, si fa riferimento a quei pochi soldi che sono stati stanziati per tali interventi.
Tra detto e non detto, frasi di 5 o 6 righe che cominciano con “Per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario”: ma qual è il “presente scenario”?
Sulla prevenzione sanitaria nelle scuole non si dice nulla, salvo sbrigative e risibili dichiarazioni sulla “cultura della salute e della sicurezza”, solo chiacchiere. L’epidemia è sullo sfondo unicamente per giustificare la sentenza: “questa è la scuola vi spetta”.
Se non ci riguardasse direttamente il documento sarebbe pieno di dettagli grotteschi, ma ci tocca ridere amaro: un ministero che annuncia “linee guida” per la “didattica integrata”, che annuncia la sua piattaforma digitale, che annuncia accordi con la Rai per programmi educativi.
Per i più grandi non c’è scampo. Per i più piccoli il ministero si preoccupa di riempire il tempo scuola “con attività integrative o alternative alla didattica”.
La scuola pubblica non è ammazzata dal covid-19 ma da questo ministero e questo governo. La “sinistra” italiana, ancora una volta, spicca per il suo zelo nella distruzione di quello che dovrebbe difendere e valorizzare.
Ricominciamo a chiamarli studenti (e tirocinanti, tesisti, impiegati, operai, ecc.) – Lorenzo Asti
Chi metta piede oggi in una scuola superiore potrà facilmente constatare l’esistenza di un fenomeno tanto singolare quanto significativo. Con le ventate riformatrici che hanno investito negli ultimi decenni le istituzioni dell’istruzione pubblica, il legislatore si è spesso preoccupato di apportare modifiche alla nomenclatura ed in particolare a quella relativa ai diversi inquadramenti dei lavoratori del settore.
Ciò nondimeno, per semplicità, continuità e forse un po’ di comprensibile nostalgia, chi la scuola la vive quotidianamente continua comunque a chiamare perlopiù preside il dirigente scolastico, bidelli i collaboratori scolastici, segretario il direttore dei servizi generali e amministrativi, applicato di segreteria l’assistente amministrativo, professori i docenti e via dicendo.
Le riforme hanno tuttavia risparmiato una delle vecchie denominazioni degli attori del mondo dell’istruzione: quella degli studenti. Anzi, coerentemente con una certa tendenza a sottolineare nelle norme un’attenzione alla parità di genere – che non disdegna comunque la galanteria di cedere il passo neutralizzando l’intento egualitario – quella “delle studentesse e degli studenti”, come recita il titolo dello statuto del 1998 che definisce diritti e doveri della componente studentesca all’interno dell’istituzione.
Malgrado ciò, gli “studenti” stanno andando incontro ad un fenomeno di rapida estinzione. Il loro posto è, nella pratica, a tutti i livelli, sostituito da una nuova figura: quella dei “ragazzi”.
A chiamare ormai di norma gli studenti “ragazzi” sono gli insegnanti, i presidi, la stampa, addirittura il Ministro, addirittura il Presidente della Repubblica.
Che c’è di male, si dirà? Dopotutto gli studenti sono anagraficamente dei ragazzi. Questa tendenza appare invece particolarmente significativa e, al di là del possibile intento affettuoso, tutt’altro che innocua.
Per un giovane in piena formazione della propria personalità e dei fondamenti della propria crescita culturale, ha una funzione indispensabile la coscienza di avere un ruolo definito nella società. Un ruolo a cui si riconosca in maniera condivisa un credito, un significato ed un senso.
Per chi in famiglia è abituato ad essere considerato, come è normale che sia, appunto, un ragazzo, il fatto di essere riconosciuto come studente ha un’enorme importanza sul piano esistenziale, dello sviluppo della personalità e della consapevolezza della propria collocazione nella comunità. Questa importanza è legata al fatto di vedersi, per la prima volta nella vita, riconosciuta ufficialmente una dignità di individuo responsabile e cosciente, un’indipendenza intellettuale, un ruolo ed un compito, appunto, nella società.
Indicare come tale uno studente, denota rispetto del processo di apprendimento e di formazione di una coscienza critica autonoma, fondata sulla conoscenza e sull’argomentazione.
Chiamando invece gli studenti “ragazzi”, mentre si omette di ricordare come andrebbe occupato il tempo a scuola, si trasmette un messaggio deresponsabilizzante, bamboccionizzante, ma soprattutto svilente. Se anche il senso della denominazione fosse anagrafico, si rischia che, in questo modo si distinguano i ragazzi non dai bambini, bensì dagli adulti, dei quali ai ragazzi è negata l’autonomia intellettuale.
Per chi metta dunque un piede oggi in una scuola superiore (in effetti si dovrebbe dire “in una scuola secondaria di secondo grado”…) sarà facile constatare come buona parte della comunità studentesca sia più o meno esplicitamente rassegnata ad senso di mancanza di significato nei confronti delle attività scolastiche e del proprio ruolo sociale. Negando agli studenti il proprio status ufficiale si rischia di contribuire a questa dinamica.
Non solo. Il termine “ragazzo” esonda frequentemente dal contesto scolastico per invadere il mondo dell’Università e del lavoro. Si chiama dunque comunemente ragazzo (se non, peggio, “ragazzotto”) il tirocinante, lo studente universitario, il tesista, il dottorando, il praticante avvocato, l’impiegato e l’operaio. Fin oltre la soglia dei quarant’anni, come se si avesse a che fare con un garzone di bottega, sottolineando la precarietà e svalutando le competenze spesso elevate e, comunque, definite e degne.
Ricominciamo a chiamare studenti i nostri cari studenti. Torniamo a dare loro credito e ruolo. Possiamo essere certi che sapranno sorprenderci.
Teledidattica: proprietaria e privata o libera e pubblica? – Maria Chiara Pievatolo
Storia di un’inchiesta che si è fatta da sé
In questi mesi, non volendo essere usata dalle piattaforme proprietarie raccomandate per la teledidattica, ho sperimentato alternative libere, e, fra queste, sia i sistemi di teleconferenza basati su Jitsi di iorestoacasa.work, sia, direttamente, quelli offerti da uno dei suoi partecipanti, il GARR.
Non potendo permettermi altro, ho provato solo quanto messo gratuitamente a disposizione per far fronte all’emergenza pandemica: e mi sono resa conto che, in Italia, non avrei potuto trovare niente di meglio dei servizi del GARR, di cui tuttavia nessuno o quasi sembrava aver sentito parlare.
E però, se lavoriamo all’università o in un ente di ricerca, GARR, anche se ne ignoriamo il nome e l’esistenza, è il terreno che abbiamo sotto i piedi: è infatti sia la rete che ci connette sia, e soprattutto, chi la gestisce: “GARR è la rete nazionale a banda ultralarga dedicata alla comunità dell’istruzione e della ricerca. Il suo principale obiettivo è quello di fornire connettività ad alte prestazioni e di sviluppare servizi innovativi per le attività quotidiane di docenti, ricercatori e studenti e per la collaborazione a livello internazionale.
La rete GARR è ideata e gestita dal Consortium GARR, un’associazione senza fini di lucro fondata sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. I soci fondatori sono CNR, ENEA, INFN e Fondazione CRUI, in rappresentanza di tutte le università italiane.”
Del GARR vale la pena leggere sia le condizioni di privacy generali, qui, sia quelle proposte, qui, per il servizio di cloud. I dati personali che raccoglie sono ridotti al minimo; e, soprattutto, nessuno dei suoi utenti viene profilato a scopo di manipolazione, pubblicitaria o d’altro genere.
Così non è, invece, per le piattaforme di teleconferenza più popolari, quali Zoom, MS-Teams, G-Suite for Education e quant’altro, i cui termini di copyright e di privacy – almeno per il loro uso apparentemente gratuito – sono variamente discutibili, come mostra, nel dettaglio, questo studio. Non a caso il governo francese ha preferito mettere a disposizione dei suoi funzionari e dei loro interlocutori un servizio di teleconferenza proprio, che gira su Jitsi, giustificandolo così:
“lo Stato ha scelto di creare e amministrare una piattaforma di teleconferenza propria, ospitata sui propri server: il suo dominio, combinato con una cifratura dei dati tramite un protocollo sicuro, offre una garanzia ulteriore di riservatezza delle comunicazioni.”
Quanto, in Francia, pare evidente per le funzioni dello Stato, dovrebbe esserlo a fortiori per la didattica e la ricerca. Anche se, per amor di discussione, ammettessimo che almeno quanto fornito a pagamento dalle grandi piattaforme proprietarie rispetti le norme europee sulla privacy e non finisca mai, nella nebulosa del cloud, in meno regolati lidi, rimarrebbe la circostanza che dati delicati vengono affidati a datacenter esteri, soggetti a scelte politiche e poliziesche altrui, e che, soprattutto, chi fornisce il servizio disegna un ambiente di opzioni predeterminate da lui e solo da lui, e non certo dai docenti, dagli studenti e dai tecnici italiani che dovranno subire sia le decisioni di chi ha comprato il servizio per loro, sia del servizio stesso.
Questi sistemi – sosteneva Edward Snowden in una prospettiva più ampia di quella sull’editoria scientifica di una più recente analisi di SPARC [1] – “sono fondamentalmente depotenzianti. Li paghi e credi di ricevere in cambio un servizio. Ma tu gli dai molto più del tuo denaro: gli dai anche i tuoi dati, e rinunci al controllo, rinunci all’influenza. Non puoi plasmare la loro infrastruttura, né cambiarla per adattarla alle tue esigenze”.
Pare, però, che questo problema non sia avvertito dalle istituzioni italiane: le università – salvo poche eccezioni, quali il Politecnico di Torino che usa e sviluppa strumenti liberi anche più efficaci di Jitsi – hanno preferito le offerte depotenzianti dalle piattaforme proprietarie. La stessa pagina del Ministero dell’Istruzione dedicata alla didattica a distanza tace, almeno nel momento in cui scrivo, su quanto offerto dal GARR: si parla solo di Google, Microsoft e TIM, dando l’impressione fuorviante che l’Italia sia un paese così povero di denaro e di spirito da non avere una propria infrastruttura per la didattica e per la ricerca. Di nuovo, conviene richiamare la Francia come termine di confronto: il sito del ministero omologo non invita a rivolgersi a Microsoft o Google, ma affida la continuità pedagogica a un ente pubblico, il CNED, con il servizio Ma classe à la maison.
Com’è possibile che le istituzioni italiane, a partire dal Ministero, ignorino il GARR, cioè una loro diretta emanazione, per consegnarsi al controllo di multinazionali private?
Una volta proposta in pubblico questa domanda, l’inchiesta si è fatta da sé. Arturo di Corinto, in un articolo del 24 marzo 2020 uscito su “Repubblica” aveva parlato dell’impegno del GARR nell’iniziativa iorestoacasa.work. IL GARR stesso ha dato e sta dando notizia dei suoi servizi gratuiti d’emergenza in un testo del 27 marzo richiamato nella sua pagina d’accesso. Federico Leva ha documentato, qui, come sia poco verosimile che il silenzio ministeriale sia dovuto a una mera mancanza di conoscenza. E, soprattutto, Giuseppe Attardi, che ha diretto per quattro anni la piattaforma cloud del GARR, ha reso pubblica sulla mailing list del centro NEXA la sua importante testimonianza, che merita una lettura attenta e integrale.
Il cloud computing è un sistema per condividere risorse di calcolo materiali e immateriali che esonera gli utenti dalla necessità di acquistarle e amministrarle distributivamente, nelle proprie sedi. Il servizio offerto può essere, con un grado di libertà e di responsabilità via via maggiore per chi lo usa, un programma, una piattaforma o un’infrastruttura. Il GARR non solo offre queste risorse, e ne ha fornito il know-how all’estero, ma sviluppa e condivide le conoscenze per amministrarle, aggiungendo anche un servizio, di cui qui, che – scrive Attardi – “consente a chi non è un sistemista o è digiuno di tecniche di virtualizzazione di creare applicazioni scelte da un catalogo”, per esempio attivando sul cloud un’istanza di Moodle per la propria scuola o la propria università.
In luogo dell’ottima risorsa pubblica che avevano in casa, i rettori, secondo Attardi, sembrano aver preferito adottare sistemi privati e proprietari perché questa opzione è apparsa loro più economica e meno gravida di responsabilità rispetto all’alternativa di assumere e formare sistemisti e programmatori padroni del loro mestiere.
Non sono in grado di calcolare se sviluppare le potenzialità del GARR sarebbe, in denaro, meno o più costoso che consegnarsi a GAFAM. È però chiaro, perfino a chi, come me, conosce l’informatica solo per sentito dire, che una comunità universitaria e di ricerca collettivamente incapace di mantenere e sviluppare un’infrastruttura propria, di controllare i propri dati e di promuovere e sviluppare competenze proprie pagherà un prezzo infinitamente alto in termini di sapere, di potere e di libertà, perché sarà sempre più dipendente – entro ambienti di scelta disegnati da altri – da sistemi e da conoscenze che non le appartengono. Non si limiterà, cioè, a mettere i propri dati sul computer di qualcun altro, fuori d’Italia, ma sarà usata da strumenti e ambienti di scelta disegnati da qualcun altro, e cioè da multinazionali private che traggono profitto dal commercio di manipolazione e sorveglianza. E formerà, per le aziende italiane, tecnici a loro volta incapaci di farne a meno, perché nient’altro è stato loro insegnato.
Non investire in Istruzione, Università e Ricerca, incoraggiando presidi e rettori a una contabilità sulla base di orizzonti ristrettissimi e grettamente competitivi, produce, evidentemente, anche questi effetti.
Non sono un’informatica. Ma da studiosa, da docente e da cittadina preoccupata mi sembra doveroso chiedere perché le istituzioni italiane hanno preferito sistemi privati e proprietari fuori dal loro controllo invece di pretendere soluzioni aperte, pubbliche e controllate da loro, e augurarmi che le risposte, se ci saranno, siano fatte oggetto di un dibattito pubblico partecipato.
La questione ha un lato tecnico che qui ho cercato di ridurre al minimo, ma il suo cuore è filosofico, politico e culturale: in un mondo che l’emergenza pandemica ha reso ancor più digitalizzato, la rinuncia a determinare i propri sistemi senza delegarli a un tutore neppure disinteressato rischia di produrre non solo un ritardo tecnologico e economico, ma, post-democraticamente, una condizione di minorità non soltanto digitale. È, in altre parole, una cosa troppo seria per lasciarla decidere agli amministratori.
[1] SPARC, Landscape Analysis The Changing Academic Publishing Industry – Implications for Academic Institutions, 2019 <https://sparcopen.org/our-work/landscape-analysis/>: “Academic publishing is undergoing a major transition as some of its leaders are moving from a content-provision to a data analytics business. This is evidenced by a change in the product mix that they are selling across higher education institutions, which is expanding beyond journals and textbooks to include research assessment systems, productivity tools, online learning management systems – complex infrastructure that is critical to conducting the end-to-end business of the university. Through the seamless provision of these services, these companies can invisibly and strategically influence, and perhaps exert control, over key university decisions– ranging from student assessment to research integrity to financial planning” (i corsivi sono miei).
“La pandemia è come un terremoto”: la “guerra lampo” della task force scuola – Giovanni Carosotti, Rossella Latempa
Proporre una riflessione sul destino della scuola italiana a partire dal rapporto finale del comitato di esperti in materia economico sociale coordinato dal prof. Colao e dal lavoro coordinato e presentato dal prof. Bianchi sulla ripartenza della scuola, pone chi scrive in una posizione d’imbarazzo, dovendo ribadire analisi e dati più volte evidenziati. D’altronde, nei documenti sopra citati, ricorrono e trovano coerenza sistemica tutte le proposte che abbiamo commentato in questi ultimi mesi, apparentemente risultati di gruppi di lavoro disparati. L’impressione più che fondata è che la politica da imporre alla scuola a causa dell’emergenza provocata dal Covid-19 fosse già decisa da tempo, e che i gruppi di lavoro nominati abbiano lavorato su indirizzi già stabiliti.
Il rapporto Colao e l’ audizione presso la Commissione Cultura alla Camera di Patrizio Bianchi fugano ogni dubbio. Dalla loro lettura pare evidente che non si intende approntare un piano di azioni contingenti, ma piuttosto dare forma a quella definitiva riconfigurazione dell’istruzione in chiave autonomistica e localistica inseguita da decenni e mai attuata pienamente. Realizzare insomma un disegno politico di trasformazione della scuola concepito a partire da altre esigenze e con diverse finalità.
Conviene dunque ritornare su alcune questioni di contenuto e di metodo più volte espresse, sia perché gli pseudo riformatori ripetono senza alcun ritegno sempre le stesse affermazioni, garantiti dall’impunità di un sistema comunicativo che non verifica la fondatezza, né pone a confronto quanto da loro sostenuto con le numerose posizioni critiche, sia per immaginare una possibile strategia di resistenza culturale.
Eviteremo però di tornare a discutere l’infondatezza di pseudo concetti la cui illegittimità –almeno se li vogliamo considerare alla stregua di paradigmi scientifici irrinunciabili- è stata già tante volte oggetto di dibattito, in particolare la leva retorica delle competenze, che ritorna ossessivamente sia nel documento Colao che nelle affermazioni di Bianchi. Né ci soffermeremo sullo strumentale richiamo ai risultati dei test PISA, per i quali la disparità degli esiti territoriali – problema diffuso in tutta l’area OCSE – non è ascrivibile a sole responsabilità didattiche. Dall’analisi di tali disparità, inoltre, non è mai è scaturita –e non lo è tanto meno adesso – alcuna pianificazione politica di interventi per quei territori in cui la scuola subisce, non genera, situazioni di effettivo disagio.
- La centralità dell’Impresa
Andiamo invece alla finalità concreta che viene prevista per la scuola italiana, in parte dissimulata ma evidente per chi è in possesso di un’adeguata capacità di lettura critica, la stessa di cui tali riformatori vorrebbero, per ragioni più che interessate, privare gli studenti delle prossime generazioni. Il punto fermo del rapporto Colao è la centralità dell’impresa, concepita quale “motore dello sviluppo, rispetto alla quale scuola e università devono costituire il “fattore chiave”, il cardine su cui imperniare un complesso di rapporti e nessi: dal diritto all’istruzione, alla riproduzione sociale, dalla divisione di genere del lavoro, alla precarizzazione, all’idea di scuola come servizio assistenziale sostitutivo di un welfare al collasso.
A partire da quest’assunto, il rapporto disegna una cornice ideologico-culturale ben nota. Partendo dal presupposto che non vada “sprecata la crisi”, non mette in discussione quel modello che proprio la crisi ha sottolineato essere distruttivo (a partire dalla gestione sanitaria lombarda e dalla retorica dell’eccellenza) ma al contrario prosegue lungo la stessa china a testa bassa, fino all’ asfissia definitiva del sistema pubblico.
Si tratta di una retorica non nuova, presente negli ultimi anni in buona parte dei diversi rapporti pubblicati dal ministero: dal Piano scuola digitale ai diversi sillabi dedicati ai vari fronti disciplinari nell’epoca delle competenze.
La strategia perseguita suona sottilmente ricattatoria: ci troviamo di fronte a una crisi economica che rischia di provocare un’enorme devastazione sociale e, se si vuole che le nuove generazioni abbiano possibilità di accesso ad un mercato del lavoro totalmente destrutturato, è necessario che il mondo dell’istruzione si pieghi alle esigenze delle imprese.
Come è facile constatare, si tratta di un’affermazione di principio non giustificata, come si è più volte argomentato in questi anni, fondata su falsi presupposti, spacciati invece per auto evidenti: in particolare il collegamento tra la precaria situazione economica del Paese e l’organizzazione scolastica, che inverte la causa con l’effetto.
Tuttavia, se l’iniziativa del privato era stata sino ad ora realizzata mediante interventi sostanzialmente indiretti o quanto meno governabili dall’impianto scolastico – pensiamo all’alternanza scuola lavoro o alla formazione docenti, alla retorica della “comunità educante” e dell’ampliamento dell’offerta formativa – qui siamo di fronte ad un decisivo salto di qualità. Le iniziative di upskilling previste dal Piano Colao – la “campagna di donazioni “Adotta una classe”; il programma di aggiornamento “Impara dai migliori”, l’organizzazione da parte di aziende e donatori delle “Gare dei talenti” – disegnano un nuovo orizzonte di partenariato pubblico privato. Si collocano nel solco del dibattito sviluppato in questi mesi da esponenti della nota filantropia capitalistica nostrana. Quella classe dirigente imprenditoriale – i vari Montezemolo, Berlusconi, Brugnoli – autoinvestitasi della sfida sociale di soccorrere il capitale umano, che occupa quotidianamente le testate dei quotidiani nazionali con iniziative come i Telethon per la scuola, oggi rese più accettabili dall’uso emergenziale delle piattaforme digitali.
Ma una denuncia del carattere estremisticamente ideologico del rapporto Colao non sarebbe completa se tralasciassimo un ulteriore aspetto che, anche dal punto di vista etico, lo rende a nostro avviso intollerabile: la pretesa di lavorare a favore dell’eguaglianza di opportunità e di una reale inclusione.
- Via il gruppo classe e largo ai patti di comunità
È all’interno di questa cornice che vanno ascoltate e inquadrate anche le parole pronunciate dal prof. Bianchi, in audizione alla Commissione Cultura della Camera, il 9 Giugno scorso, in occasione della presentazione delle “proposte per la scuola con riferimento all’emergenza sanitaria e al miglioramento del sistema di istruzione nazionale” [1].
L’intera relazione di Bianchi si comprende appieno proprio alla luce della logica di privatizzazione. Si tratta in fondo delle consuete ricette liberiste, quei mantra manageriali rimestati oramai da 30 anni e riproposti incredibilmente quale avanguardia di un progetto d’inclusione e di lotta alle disuguaglianze. Tali disuguaglianze non vengono analizzate o riferite a concrete situazione sociali ed economiche, ma motivate soprattutto sulla mancanza di competenze metodologiche da parte dei lavoratori della scuola. Un approccio totalmente diverso, fondato sul digitale, garantirebbe magicamente eguali condizioni d’apprendimento.
Con la consueta retorica che fa appello ai concetti di comunità e di socialità, l’indirizzo che il comitato di esperti suggerisce al governo, in perfetta continuità con lo spirito delle riforme che lo hanno preceduto, è nei fatti la totale delega, da parte dello Stato, della gestione e della regolazione dell’istruzione pubblica. Esattamente come accaduto per la Sanità, per la quale lo Stato ha progressivamente ma sostanzialmente “rinunciato ad esercitare i poteri di cui dispone” limitando di fatto “il proprio ruolo al contenimento della spesa, lasciando gli indirizzi di politica sanitaria” [2] ai territori (nel caso specifico, le Regioni), così per l’istruzione siamo giunti all’atto finale di quel processo che da Berlinguer a Renzi ci porteranno alle scuole dei “patti di comunità“.
Come un simile scenario possa agire su quelle disuguaglianze che pure si dichiara di voler superare, non è dato sapere. Nessuna traccia, se non pure petizioni di principio, in merito al tema cruciale del divario Nord -Sud o dei divari interni alle varie realtà e zone del paese (centri-periferie, di genere o di provenienza degli studenti, di indirizzi scolastici, etc).
Pare poi addirittura incredibile che in nome dell’immagine di “territorio educante” e del patto locale di comunità debba essere sacrificata proprio la prima comunità in cui si misura e si realizza la crescita culturale di ciascuno studente: il gruppo classe. L’idea distorta di un’ uguaglianza che si attua soltanto attraverso l’individualizzazione dei percorsi e delle proposte educative, già fondamento del documento politico dei dirigenti dell’Associazione Nazionale Presidi di recente pubblicazione, è centrale nella proposta Bianchi:
“Il concetto di classe, come definizione amministrativa è superato. La classe è una microcomunità in cui potere sviluppare le diverse capacità dei ragazzi. Gruppi più piccoli permettono all’insegnante di dare supporto personalizzato che oggi è quello che si pretende e che si deve poter dare. Sta nascendo questo concetto di uguaglianza che sembra molto forte, la capacità di permettere ad ognuno di essere diverso, dunque bisogna ascoltare ognuno”.
“siamo stati troppo concentrati sull’idea che la media italiana [degli spazi d’aula] era di 45 metri. Abbiamo cominciato a ragionare sugli esterni. Ma ragionare sugli esterni non vuol dire fare all’esterno la stessa cosa che facevi all’interno. Significa cambiare modello didattico [..]
Utilizziamo questa tragedia per riportare la scuola al centro di un dibattito che dica cosa deve essere insegnato ai nostri ragazzi per permettere di star bene a scuola e per avere anche quel volano fondamentale per lo sviluppo. [..]”
In realtà ciò che viene meno è proprio l’idea stessa di comunità, favorita in particolare dall’esperienza del gruppo classe; si propone peraltro una falsa individualizzazione, per il fatto stesso che la trasmissione didattica avverrebbe secondo modalità formalizzanti, ben sintetizzate dall’espressione «percorsi didattici progettati» [3], che chi conosce la logica delle Unità di Apprendimento sa ben decodificare. In realtà ciò che si vuole disgregare è l’autentica dinamica collettiva e cooperativa fondata sul gruppo classe, per impedire al singolo di sottrarsi al processo di condizionamento con cui si intende determinarne la soggettività, per formare personalità subordinate, plasmabili, adatte a integrarsi in un mercato del lavoro iniquo, senza peraltro avere gli strumenti per metterlo in discussione.
- Soft and collaborative problem solving skills
Venendo alle proposte concrete, ritorna nella relazione Bianchi tutta la retorica delle soft skills, mai- evidentemente – definite in modo rigoroso:
“oggi quello che è indispensabile per la scuola è [..] disegnare le nuove competenze per lo sviluppo. Una volta lo sviluppo era dato da competenze lineari, gerarchiche, ripetitive. Oggi le competenze per lo sviluppo del paese sono date dalla creatività, dalla capacità di mettere insieme le persone. Quella che l’OCSE chiama le collaborative problem soving skills, su cui noi siamo [..] sotto la media. Collaborative, problem solving skills, competenze per risolvere i problemi insieme”.
L’emergenza, dunque, va collocata all’interno di una “visione lunga”, che richiederebbe una completa ristrutturazione di sistema, sintetizzabile su 2 piani, reciprocamente connessi: nuovo ruolo e formazione docenti e nuovo ruolo del territorio.
“Oggi la logica dell’impresa è tutta basata sulle soft skills, cioè la vera competenza richiesta è mettere insieme persone diverse facendole operare insieme, giocare insieme, suonare insieme, lavorare insieme. Al di là della specifica competenza disciplinare.”
Sulla base di questo assunto, per “tornare ad avere l’orgoglio di essere insegnante” sarà necessario, a parere del comitato di esperti, ridisegnare la figura professionale, in particolare della scuola secondaria di secondo grado. Oltre ad una formazione con “supporto psicologico”, ad un “equipaggiamento per la gestione delle emozioni”, ad una “formazione tecnologica [..] non soltanto sulla desterity [dei nuovi strumenti] ma anche sul judgement”, occorrerà ripensare le attività quotidiane, soprattutto sulla base di due aspetti inizialmente resi necessari dal protrarsi di una situazione di emergenza, ma che a regime potranno diventare strutturali: la “riarticolazione sul territorio” e la “rimodulazione del tempo delle lezioni”.
Proprio il binomio territorio-autonomia, che ha mostrato in questi anni tutto il suo vuoto retorico e la sua drammatica concretizzazione in disuguaglianze incolmabili, viene ancora e sorprendentemente riproposto come panacea e risposta all’emergenza.
“La rimodulazione del tempo delle lezioni si deciderà. Lo deciderà il collegio, gli organi collegiali. Ma il tempo di differenza non deve essere razionalizzazzione, ma ascolto dei singoli studenti, o tempo per essere più fuori, sul territorio. L’offerta didattica deve riuscire a tenere dentro anche le attività che verranno fatte con i patti educativi di comunità. [..]
Le attività di socializzazione non sono sotto-materie. La musica di insieme, lo sviluppo delle attività artistiche, la capacità di usare il computer anche per il gaming, per le attività di educazione civica vissuta nel territorio, la capacità di lavorare sullo sport che vuol dire la propria corporeità. Sono materie che già esistono ma sono materie in cui hai un’ora, due ore. Sono confinate. Nel dibattito queste diventano invece fondamentali e sono fatte insieme col territorio..”
E ancora:
“La scuola deve essere al centro del territorio, il motore del territorio. [..] i patti educativi di comunità [permetteranno] di coinvolgere il territorio nella gestione ordinaria della vita scolastica, non nelle gite scolastica. Vado nel territorio perché lì ci sono quelle materie che non solo fanno la nuova socialità, ma fanno anche le competenze del vivere in una comunità aperta, oggi troppo conflittuale e che invece deve tornare a vivere coesa.
[..]
La pandemia è come un terremoto. [Bisogna] andare verso semplificazioni formative; valorizzare tutti gli attori formativi: insegnanti, sostegno, educatori, coloro che potranno apportare esperienze, per i grandi le esperienze delle imprese..”
Se ciò che il coordinatore del comitato tecnico dice può apparire destabilizzante, lo è ancor più ciò che non dice. La recente evoluzione normativa in tema di valutazione e le spinte politiche più o meno evidenti che lavorano da decenni in questa direzione, aggiunte alle apparenti necessità di personalizzazione e superamento del concetto di classe di studenti, conducono irrimediabilmente ad una ridefinizione in chiave di certificazioni individuali della valutazione scolastica. Questo voleva l’Europa fin dai tempi del Libro Bianco di Edith Cresson (1996), questo richiamavano prima Moratti (2003) poi Checchi, Ichino e Vittadini (2008) e questo reclamano oggi l’Associazione Nazionale Presidi e le associazioni datoriali.
- Una unanimità politica desolante
La drammatica panoramica proposta su un processo di accelerazione della distruzione della scuola che però, per i lettori di Roars, non rappresenta certo una novità, rinnova l’indignazione per il credito che trovano teorie così ostili ad un onesto confronto intellettuale. Ma ciò che più di tutti sorprende, sgomenta, indigna è la reazione unanime di consenso da parte praticamente di tutte le forze politiche, come è evidente dagli interventi registrati proprio alla Commissione Cultura della Camera. Riportiamo qui i più significativi.
Francamente, spenderemmo un elogio per Valentina Aprea, il cui pensiero coincide con il nostro quando, dopo aver ascoltato l’audizione di Bianchi dichiara: “questo rapporto è musica per le mie orecchie”; per poi rivendicare l’appartenenza di tale modo di intendere la cultura al centro-destra, ammettendo tutto il carattere reazionario del progetto e invitando a una modalità di azione politica (da lei intesa come “suggerimento metodologico”) indifferente nei confronti della dialettica democratica:
“Il mio timore è che tutto finisca come per il gattopardo. Tutto cambia perché nulla cambi. Questa volta non deve essere così.”
Come una novella Giorgio Sidney Sonnino, la Aprea si richiama allo spirito de Torniamo allo Statuto, dove il politico alla fine del XIX secolo auspicava che l’esecutivo rendesse conto unicamente al sovrano, ignorando il Parlamento. Dice la Aprea:
«Parto da un suggerimento metodologico. Non abbiamo bisogno di norme, ma di regole in protocolli vincolanti. [..]
Stia lontano dal Parlamento! Decidiamo punto per punto, ma non le leggi!
Meglio un provvedimento temporaneo, emergenziale per davvero. Non nuove norme. Abbiamo bisogno presto di protocolli vincolanti per una fase che comincia domani, da sperimentare almeno fino a dicembre. Buttiamo dentro le deroghe della scuola e che siano chiare subito. Questi protocolli vincolanti devono contenere anche i finanziamenti. Subito! Potete essere più coraggiosi. C’è l’interdisciplinarietà. L’area della socializzazione deve essere più estesa. Fare musica è anche fare matematica. Più coraggio!».
In fondo, più prudente e raffinato, seppur analogo nella sostanza, è il suggerimento del deputato Alessandro Fusacchia, che ricordiamo tra gli autori del rapporto La Buona Scuola, quando afferma:
“Siamo pochi gg dopo un decreto sulla scuola e stiamo presentando degli emendamenti al decreto rilancio, dove ci sono capitoli sulla scuola, ieri è uscito il rapporto Colao. Sta finendo l’anno scolastico […]
Sottoscrivo e sottoscriverei tutto ciò che ho sentito. Alcune cose sono suggestive e nuove, altre sono cose con cui si fa i conti da decenni. Come facciamo a fare quello che si sta dicendo?
Lei parla di interventi normativi. Quando e dove? [..] nei veicoli normativi che esistono in questa fase, inseriamo interventi dirimenti.
Nel momento in cui a settembre torniamo alla normalità, è finita [..]
Abbiamo poche settimane per mandare a regime ciò che lei ha presentato e che io sottoscrivo.”
Una prudenza solo apparente, dal momento che anche in questo caso il suggerimento è trasformare la scuola attraverso emendamenti al decreto rilancio, sottratti di fatto al dibattito pubblico e senza alcun confronto con l’opinione della classe docente, da nessuno considerata parte in gioco, ma solo un insieme di amorfi operatori che attende e accetta prescrizioni provenienti dall’alto.
Ma è ascoltando la replica di Nicola Fratoianni, che rimaniamo allibiti.
“Trovo molto interessante il quadro proposto e anche le indicazioni che emergono in questa fase del vostro lavoro. Credo che l’approccio che ci ha presentato ha il merito di fare quello di cui credo in questo momento abbiamo davvero bisogno. Penso che questa drammatica crisi … offra una formidabile occasione: rimettere al centro del dibattito pubblico e dell’iniziativa politica di questo paese la scuola, dopo anni in cui la scuola è finita un poco ai margini delle priorità, del dibattito e dell’elaborazione e delle priorità della politica. [..]
Le cose che lei ci ha detto ci parlano di come riorganizzare la didattica, cosa studiare in questo momento. [..]. Io mi auguro che questo impianto ad un certo punto determinerà le scelte politiche. … Mi batterò per questo.”
A oltre 20 anni dal progetto di autonomia scolastica inaugurato da Berlinguer, il cerchio dunque si chiude: l’idea di istruzione e il modo di intendere la cultura, rivendicati giustamente dal centro destra attraverso le parole di Valentina Aprea, mettono oggi d’accordo proprio tutti. La politica, compresa l’attuale sinistra, sembra incapace di comprendere l’ orizzonte culturale sotteso a una trasformazione così radicale, come quella concretamente prefigurata dalle proposte del comitato Bianchi. O forse è semplicemente connivente e subalterna alla logica neoliberista dominante. Se, e in che misura, l’indirizzo della task force si tradurrà in azioni concrete a partire da settembre lo capiremo a breve. Potrebbe essere una guerra lampo.
[1] Le citazioni riportate di seguito sono trascrizioni degli interventi del prof. Bianchi e dei parlamentari partecipanti al dibattito, reperibili al link: https://www.radioradicale.it/scheda/607855/commissione-cultura-scienza-e-istruzione-della-camera-dei-deputati.
[2] M. Villone, “Lo Stato ha rinunciato alla sanità”, Repubblica Napoli, 11 Giugno 2020.
[3] Documento “Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022”, punto 78, pag. 36.
Scuola: di cosa hanno bisogno i docenti? – Marco Meotto
“Ne usciremo migliori o peggiori?”: era questa una delle domande che circolava durante le confuse settimane della quarantena di massa. A pensarci meglio, si intravedeva già un leggero smottamento prospettico rispetto all’iniziale, più rassicurante e apotropaico, “andrà tutto bene”.
Che si tratti di fase 2, fase 3 o che altro, ora che – si dice – il paese sta ripartendo, gli interrogativi su come ne siamo usciti possono essere declinati in vari ambiti. Quello della scuola resta un terreno in cui le incognite continuano a superare gli aspetti noti.
Se ne è parlato molto, ma, di certo, se ne parlerà ancora, soprattutto quando arriverà l’attesa relazione della task-force istituita dal Ministero dell’Istruzione e presieduta da Patrizio Bianchi. Nel frattempo, in queste settimane che hanno accompagnato alla conclusione l’anno scolastico, si sono accese discussioni sulla scuola che verrà, anche sulla base di documenti, proposte, piattaforme che provano, da punti di vista molto lontani, a prospettare scenari o a rivendicare cambiamenti per il futuro. Così, mentre i docenti si cimentavano con le sottili implicazioni di tipo burocratico nascoste nelle pieghe delle Ordinanze ministeriali sugli esami di stato e sulla valutazione e mentre le Camere, affannosamente, convertivano in legge il Decreto sulla scuola, si assisteva anche alla riconquista delle piazze da parte di comitati di genitori e insegnanti e da parte dei sindacati che, in forme eterogenee, manifestavano il proprio malessere e scontento nei confronti dell’agire – o, forse, del non agire – del Ministero.
Anche per la pluralità dei soggetti coinvolti, il tentativo di mappare cosa si muove nel discorso pubblico attorno alla scuola non è certo semplice, ma è indubbiamente un esercizio utile, in quanto specchio delle riconfigurazioni e ristrutturazioni più profonde che riguardano l’intera nostra società.
Proposte spudorate: la scuola dei manager
Gli elementi di rottura hanno spesso il vantaggio di chiarire la posta in gioco. Si può quindi cominciare la ricognizione dal documento più discusso: le proposte avanzate dell’ANP, l’Associazione Nazionale Presidi. L’articolata riflessione prodotta dall’ala più oltranzista tra le organizzazioni di categoria dei dirigenti scolastici sottolinea la necessità di apportare profonde modifiche all’assetto complessivo del sistema d’istruzione. In questo senso la minaccia del Covid-19 è declinata tutta in termini di opportunità: sarebbe l’occasione che la scuola non deve lasciarsi sfuggire. Di quali trasformazioni stiamo parlando?
Chi già ne conosce le posizioni non si sarà stupito a leggere che gli assi portanti della proposta dell’ANP sono l’ennesima riproposizione della concezione manageriale del governo delle scuole, la non certo inedita richiesta di abbattere le rigidità che mortificano le capacità di gestione dei dirigenti e l’accorato appello a riformulare i curricoli puntando al superamento dei saperi disciplinari in nome delle agognate “competenze”. Non si tratta di novità sostanziali, ma ciò che davvero colpisce è in qualche modo la schiettezza – verrebbe da dire la spudoratezza – con cui certe direttrici vengono tracciate.
Sin dalle scelte lessicali di frasi quali “alla scuola è rivolta una domanda di erogazione di servizio che produca apprendimento” si intuisce che la dimensione in cui si vuole collocare l’istituzione scolastica di domani è, una volta di più, quella dell’agenzia al servizio dei “portatori di interesse”, i fantomatici stakeholder, che poi, riducendo il discorso all’osso, sarebbero le imprese. Come vedremo nel seguito del ragionamento, ci sono brillanti analogie tra le proposte dell’ANP e i suggerimenti pratici contenuti nel Piano Colao, quasi che i due documenti fossero scritti da persone che si riconoscono nei medesimi riferimenti politico-culturali. Varrà quindi la pena abbozzare una riflessione che delinei quali preoccupanti prospettive pedagogiche possano scaturire da questa sinergia. Restiamo per ora agli aspetti organizzativi della scuola auspicata dall’ANP.
Un’urgente necessità sarebbe, ad esempio, “liberare il ruolo dirigenziale da vincoli e costrizioni”. Il che fa pensare a poveri presidi assediati e tiranneggiati da orde giacobine di docenti che li minacciano con lo spettro della ghigliottina. Lo può credere solo chi non è mai stato in una scuola negli ultimi vent’anni. Invece si tratta semplicemente, detto in soldoni, della richiesta di azzerare i decreti delegati e le norme che, almeno in via teorica, rendono democratica l’istituzione scolastica attraverso gli organi collegiali. Non è un’interpretazione ardita, c’è proprio scritto così, laddove si legge che è opportuno “l’aggiornamento della governance delle scuole, cioè delle competenze degli organi collegiali, anacronisticamente ferme alle disposizioni legislative emanate nel lontano 1974”. Anche questo registro linguistico non suona nuovo. Esso caratterizza l’ordine del discorso che – sotto governi di diverso colore, ma accomunati dalla piena adesione all’ideologia neoliberale – ha accompagnato e giustificato lo smantellamento, in altri settori, di molte garanzie sociali e conquiste democratiche. Insomma, quasi si sente l’eco lontana della battuta di Renzi sui sindacati fermi al telefono a gettone, mentre il resto del mondo usa l’i-phone: era il 2014 e l’ex presidente del consiglio si apprestava a picconare l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, anche questo, ovviamente, anacronistico. Di lì a poco sarebbe toccato alla scuola con la legge 107, in cui era contenuto il disegno, poi in parte arginato, di dare ai presidi poteri nuovi, più ampi e più discrezionali.
Lo si scriveva già due mesi fa: lo stato d’eccezione, con i Dpcm a riporre nelle mani dei dirigenti scolastici compiti inediti, con la ministra Azzolina a investire i presidi del ruolo di “comandanti della nave”, ci suggeriva di tenere alta la guardia rispetto alla possibilità che si realizzasse ciò che non era riuscito alle contestatissime riforme della scuola degli ultimi vent’anni.
Ed ecco che lo spettro si è fatto concreto. Nelle conclusioni del proprio documento i presidi dell’ANP rivendicano apertamente la “valorizzazione del ruolo dei dirigenti scolastici in materia di scelte organizzative e gestionali, sull’esempio di quanto avvenuto durante la fase emergenziale […].” Aggiungendo poi che devono essere eliminati “i vincoli burocratici e gli ostacoli organizzativi che impediscono ai dirigenti di assumere con la dovuta celerità le decisioni inerenti alla gestione delle risorse umane, economiche e logistiche. Così come si deve ridurre – e auspicabilmente eliminare – la tendenza del Ministero dell’istruzione a dettare regole di gestione del quotidiano, soprattutto in materia di personale.”
Del celebre binomio “efficacia-efficienza”, a cui dovrebbe guardare l’azione della pubblica amministrazione, in questa visione si impone soprattutto il secondo termine: lo stato d’emergenza – sembrano dirci i presidi – ha dimostrato che le scuole funzionano efficientemente solo se le catene di comando che le governano non trovano intoppi. Così arriviamo a un’altra richiesta, anche questa non nuova: l’introduzione del middle management, cioè di figure di docenti che fungano da “quadri intermedi” e che, ben oltre l’attuale concetto di staff, coadiuvino il preside-manager nel governo della scuola. Per dirla con le parole dell’ANP, servono figure di “supporto al potere organizzativo detenuto dalla dirigenza scolastica”. Solo così il modello aziendale può davvero dispiegarsi.
Una vecchia storia: l’innovazione per l’innovazione
Uno dei tranelli nei quali il discorso attorno alla scuola si trova a incespicare maggiormente è la contrapposizione tra vecchio e nuovo, o una delle sue numerose riformulazioni, come la coppia “tradizionale-innovativo”. Sulla base di questa dicotomia si diffonde un vero e proprio riflesso condizionato secondo cui alla scuola serve soprattutto innovazione, come se la radice dei suoi problemi fosse tutta dovuta a un eccesso di conservatorismo. Eppure è da oltre vent’anni – cioè dal varo dell’autonomia – che, riforma su riforma, chiunque si sia seduto sulla poltrona ministeriale di viale Trastevere non ha fatto altro che insistere sui temi dell’innovazione.
L’immagine di un sistema d’istruzione polveroso, novecentesco, poco incline al cambiamento, è la classica menzogna che viene creduta dall’opinione pubblica solo perché ripetuta incessantemente. E questa immagine è anche una trappola ideologica, perché diviene la leva con cui liberarsi di ciò che ha reso la scuola, seppur tra mille difficoltà, un vero “bene comune”.
Spesso la riflessione sull’innovazione si trasforma in una mera questione di strumenti tecnologici e di addestramento degli insegnanti a utilizzarli. Bisognerebbe però leggere con occhio critico la storia dell’innovazione informatica nella scuola sino ad oggi, per accorgerci che – acronimo dopo acronimo – non sono certo state le azioni di sistema a mancare. Siamo passati dai PNI (Piani Nazionali Informatici) degli anni Ottanta e Novanta al PSTD (Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche), quindi al For.TIC (Formazione degli insegnanti alle Tecnologie Informatiche) e infine al PNSD (Piano Nazionale per la Scuola Digitale), inserito nella “Buona Scuola” di Renzi, che avrebbe dovuto guidarci definitivamente verso le classi 2.0. A mancare quindi non sono stati certo gli investimenti nell’innovazione: più interessante sarebbe chiedersi cosa e come lo si vuole innovare.
Al fascino dell’innovazione non si sottraggono nemmeno i più recenti documenti sindacali. Se sfogliamo la proposta per il rientro a settembre della Cisl Scuola – probabilmente il più conciliante tra i grandi sindacati rappresentativi – troviamo con insistenza riferimenti a “nuove linee pedagogiche”, “nuovi modelli didattici”, “approcci nuovi”, “nuove modalità di insegnamento/apprendimento”. Il pur apprezzabile tentativo di superare una scuola gentiliana, tutta basata sulla frontalità, si perde però in un sostegno vago a ciò che è nuovo. Di cosa si tratti di preciso quindi non lo si capisce. Si lascia implicita l’inferenza secondo cui ciò che è nuovo sia, naturaliter, buono ed efficace. Insomma il rischio è che le intenzioni della Cisl aprano la strada a una curiosa eterogenesi dei fini: toni simili, infatti, li possiamo scorgere proprio nel già citato documento dell’ANP, che molto insiste sull’assoluta necessità di preparare il personale all’innovazione tecnologica e didattica.
Nel tentativo di capire meglio in cosa consista il costante richiamo all’innovazione, ecco che allora scorgiamo lemmi conosciuti: l’Associazione Nazionale Presidi chiede infatti che ai docenti siano imposti corsi di formazione su “didattica per competenze, flipped classroom, PBL [Project Based Learning, ndr], EAS [Episodi di Apprendimento Situato, ndr], educazione ai media e, in generale, su tutte le metodologie innovative”. Quest’ultimo termine – metodologie innovative – ha un’aura così generica da renderlo quasi un sintagma desemantizzato: ha perso ogni reale significato puntuale e definisce semplicemente qualsivoglia metodologia di là da venire. Spesso, in un eterno ritorno dell’identico, sono pratiche vecchie e nuove allo stesso tempo, come l’insistenza sui metodi attivi che ormai hanno compiuto un secolo e che, in una memorabile pagina di Il maestro di Vigevano, erano già fatti oggetto di ironia da Lucio Mastronardi esattamente sessant’anni fa.
C’è però da chiedersi se, nella fase post-emergenza come in tempi di normalità, siano davvero questi gli assi di formazione di cui i docenti avranno preliminarmente bisogno. Diciamolo in altri termini: qual è la vera esigenza formativa di un docente? Colmate le lacune tecnologiche o sistematizzate le conoscenze acquisite sul campo durante l’esperimento collettivo della DaD, bisognerà concentrare tutta l’attenzione ancora e comunque sull’educazione digitale? I docenti hanno solo bisogno di inseguire innovazioni metodologiche (che poi innovazioni non sono) o forse è meglio che si aggiornino costantemente sui nuclei fondanti delle proprie discipline, sul dibattito scientifico delle materie che insegnano e sugli avanzamenti negli studi dell’ambito psico-pedagogico? E ancora, senza voler ridurre lo statuto disciplinare della didattica – e delle sue articolazioni – a mera tecnica, ma anzi proprio per volerlo salvare da un progressivo deterioramento, è mai possibile che gli aggiornamenti sulle specificità della didattiche disciplinari siano relegati alle scelte dei singoli docenti? Infine ci si può ancora domandare se l’ormai annoso dibattito sulle competenze si arricchisca o si svilisca nell’uso che del costrutto viene quotidianamente fatto.
Una risposta, per certi versi definitiva, ce la suggeriscono le schede che trattano di scuola del Piano Colao.
È qui che leggiamo del progetto “Partnership per upskilling”, che sarebbe finanziato sostanzialmente da imprese e privati, a cui spetterebbe il compito di colmare il gap tra la percentuale del PIL che l’Italia destina all’istruzione (3,8%) e la media di ciò che avviene nei paesi europei (4,6%). Uno dei perni sarebbe l’azione specifica denominata “Impara dai migliori”, la cui descrizione è bene lasciare al testo originale: “programma nazionale coordinato di ‘aggiornamento degli educatori’ per il quale 20 sabati all’anno grandi aziende high tech, enti di ricerca e università fanno corsi di aggiornamento su temi innovativi agli insegnanti di liceo e medie”. In un altro punto del piano si evoca un fantomatico “diritto alle competenze”, necessario per assecondare le richieste del mondo delle imprese, così come si segnala la necessità di formare le giovani generazioni allo sviluppo del proprio “capitale psicologico”.
Quale che sia la migliore – e quindi la meno strumentale e terra terra – accezione con cui intendere l’apprendimento per competenze, è ormai palese che, attraverso questo grimaldello concettuale, si cerca di veicolare una precisa ideologia, quella della competizione degli individui sul mercato.
Guardare in faccia il futuro
Ed è anche a questo proposito che, pensando alla ripresa, bisogna riflettere sul tema della formazione dei docenti. È un argomento che, nei documenti sindacali, non viene analizzato con la giusta profondità. La “Piattaforma per il rilancio del sistema scuola” a cura della FLC-CGIL si limita a chiedere un “Piano di formazione specifica”, declinato sulla base dei bisogni locali dei territori e delle singole scuole e strutturato su due grandi articolazioni: “l’utilizzo consapevole delle tecnologie di smart learning” e il supporto ai bambini e ai ragazzi “nel recupero emotivo delle fratture subite, nel recupero del tempo perduto, nel rafforzamento dei legami tra pari perso per le regole del distanziamento interindividuale”. Due campi di intervento certamente importanti, ma forse c’è bisogno anche di altro.
Il Piano Colao e le proposte dei presidi dell’ANP ci pongono di fronte agli occhi un’idea precisa di scuola: è un disegno che vuole tenere insieme il filo rosso che lega la spinta liberista impressa negli anni Novanta con il Libro Bianco di Cresson e Flynn alle riforme dell’istruzione che hanno, tassello dopo tassello, trasformato la scuola da strumento di affermazione e emancipazione dalla propria condizione di origine in luogo di riproduzione sociale al servizio delle imprese. Non sono borbottii ideologici: ce lo dicono i dati Invalsi e ce lo raccontano migliaia di RAV e Ptof in cui sta scritto a chiare lettere che la tale scuola è frequentata da figli di professionisti e upper-middle class e la talaltra raccoglie gli italiani di seconda o terza generazione e chi proviene da famiglie in condizioni sociali di debolezza.
Vale la pena chiedersi se sia applicabile anche alla scuola, la frase che il compianto Luciano Gallino usava per spiegare il senso del titolo di uno dei suoi ultimi saggi di successo (La lotta di classe dopo la lotta di classe, Feltrinelli, 2012): “la caratteristica saliente della lotta di classe alla nostra epoca è questa: la classe di quelli che da diversi punti di vista sono da considerare vincitori sta conducendo una tenace lotta di classe contro la classe dei perdenti”. Dobbiamo e possiamo chiedercelo in ragione delle suggestioni per la scuola del futuro che ci sono proposte. C’è chi – come Giovanni Carosotti e Rossella Latempa – ha scritto che si tratta di un progetto politico che ha come obiettivo esplicito la fine della scuola della Costituzione.
Se vogliamo usare altri attrezzi concettuali, possiamo affermare che la scuola del domani più prossimo rischia di essere la scuola dell’assoggettamento e non quella della soggettivazione, per usare le due categorie che, di recente, ha con lucidità evocato Girolamo De Michele. È però opportuna una chiosa per evitare il più tipico dei bias cognitivi. Non si tratta di contrapporre un’idea di scuola ancorata al passato con una aperta verso il futuro: si finisce così con il dare ragione al conservatorismo della predella à la Galli Della Loggia.
La questione è tutta proiettata verso il domani e ruota sulla possibilità di decidere gli spazi dentro cui si andrà a sviluppare l’istruzione pubblica che verrà.
Ma la denuncia, per quanto necessaria, non basta. Non è sufficiente denunciare i disegni di una controparte che ormai non ha più remore ad affermare che i privati devono investire nell’istruzione, che la scuola deve essere al servizio delle imprese, che gli studenti necessitano di una formazione che li renda competitivi nel mercato del lavoro. Il problema è davvero quello di aprire un ampio dibattito pubblico che abbia il coraggio di delineare proposte pedagogiche e visioni coraggiose in grado di risvegliare passioni e voglia di lottare per un bene – la scuola – che dovrebbe essere sentito come di tutti.
Organizzarsi
Primi, timidi segnali, si sono visti con le manifestazioni – svoltesi pur con il distanziamento fisico – di fine maggio e inizio giugno: ha cominciato il comitato “Priorità alla scuola” e poi sono seguiti, in ordine sparso, prima i sindacati di base (Cub, Cobas, Adl-Cobas, Usb) e poi i sindacati confederali con lo sciopero dell’8 giugno. C’è da sperare che la volontà di marcare le proprie differenti posizioni – dopotutto compresse nella sfera virtuale durante il lungo periodo di contenimento dell’epidemia –, possa lasciare spazio e margini per percorsi maggiormente unitari.
Se vogliono essere gli insegnanti a ridare fiato a un dibattito pedagogico e culturale – e dovranno presto intessere un dialogo con gli studenti, le famiglie e altri settori della società – è bene però che si interroghino da subito sulla loro funzione sociale: su ciò che essa è, come su ciò che vorrebbero che fosse.
Nel mondo anglosassone c’è ormai una diffusa concordia riguardo al fatto che gli insegnanti si sono trasformati da professionals a street-level bureaucrats. Non è una questione di “svilimento” del mestiere, è la consapevolezza che si tratta di tasselli fondamentali all’interno di un reticolo di servizi essenziali. È bene non scordare che è proprio da questa consapevolezza del loro ruolo sociale che, nel biennio 2018-19, negli Stati Uniti gli insegnanti hanno occupato le scene pubbliche con un incessante e tumultuoso movimento di protesta: scioperi a oltranza, marce sulle sedi amministrative e vertenze vittoriose hanno avuto luogo in una decina di stati.
Ovunque, accanto a una scottante questione salariale che ci mostra che tutto il mondo è paese, gli insegnanti statunitensi rivendicavano investimenti a garanzia del ruolo di presidio sociale e culturale che devono essere le scuole: meno allievi per classe, meno potere ai direttori scolastici, più assistenti sociali e psicologi, dipartimenti medici per le scuole polo, più dignità alle discipline, fine del competence-based learning. Sono le stesse rivendicazioni che, oggi, nella scuola post-Covid 19 varrebbe la pena di avanzare ovunque, se davvero – come si diceva – ne vogliamo uscire migliori.
Docenti senza corpo – Anna Angelucci
La locuzione latina habeas corpus viene posta in Occidente a fondamento giuridico della salvaguardia della libertà individuale contro detenzioni arbitrarie ed extragiudiziali. Il principio di inviolabilità dei diritti fondamentali della persona avviene, in primis, attraverso il riconoscimento del suo corpo materiale, che non può essere sottoposto ad alcuna violenza fisica o morale, né arbitrariamente violato in alcun modo. La tecnologia digitale e l’uso pervasivo dei suoi strumenti in settori sempre più ampi della nostra vita privata e sociale stanno incidendo profondamente sul concetto di persona, anche rispetto alla nostra stessa auto-percezione. E, con la diffusione incrementale di pratiche di dematerializzazione, possibili proprio in ragione dei nuovi strumenti informatici, anche il concetto di persona fisica insieme al perimetro del nostro corpo stanno vertiginosamente cambiando. Non sono pochi gli scienziati che attribuiscono allo smartphone la funzione di un nuovo arto, né quanti studiano le modifiche dei nostri apparati motori e gestuali a partire dalle mani, strutturatisi nel tempo lungo dell’evoluzione, alla luce dei nuovi usi di questi artefatti digitali. Al nostro corpo fisico – che continua a soddisfare i suoi bisogni materiali essenziali in una quotidianità apparentemente immutata nelle sue condizioni biologiche costanti – si sta progressivamente accostando un alter ego digitale, plasmato attraverso le innumerevoli informazioni personali che ciascuno di noi nel mondo, più o meno liberamente, cede alle aziende di big data analitycs and intelligence: il risultato sembra essere oggi l’istituzione del principio della profilazione come nuova creazione collettiva dell’individuo del terzo millennio, protagonista di una second life virtuale che sempre più si sostituisce e marginalizza la vita reale.
Scuola e università sembravano resistere, se pure a fatica, a questo processo di naturalizzazione della trasformazione digitale dell’umanità e del mondo. Una trasformazione che rifiuta qualunque contrapposizione tra virtuale e reale in nome della tecnologia che abbatte questa distinzione e che rende il virtuale reale giocando sulla percezione che noi abbiamo del fenomeno, indipendentemente dalle sue proprietà intrinseche. Ma, se questa è la condizione umana del bambino o dell’adolescente nativo digitale, certamente non lo è per la stragrande maggioranza dei docenti della scuola e dell’università, in larga parte indisponibili alle lusinghe dell’industria produttiva 4.0, che da anni tenta di afferrare la didattica con la sua longa manus per fare profitti in un segmento di mercato ancora piuttosto vergine.
Come docenti, non abbiamo accettato la consegna dei corpi e la resa incondizionata alle LIM, ai tablet, ai computer e agli smartphone come surrogati delle nostre lezioni in presenza. Non abbiamo smesso di parlare, di spiegare, di studiare, di fare ricerca e raccontare ai nostri studenti quanto venivamo imparando strada facendo o avevamo imparato in passato, desiderosi di trasmetterlo a loro, nel circolo virtuoso di un pensiero e di una cultura instancabilmente critici. E quanto più scuola e università venivano assediate e lentamente penetrate da venditori di prodotti informatici d’ogni tipo, e quanto più le istituzioni pubbliche e i Governi si facevano portavoce delle istanze private dei piazzisti dell’istruzione [2] abilmente dissimulati in eleganti think tank che mescolano il gotha dell’imprenditoria confindustriale con i nomi rasserenanti dei benpensanti di centrosinistra, tanto più scuola e università hanno opposto una resistenza fisica, in alcuni casi oserei dire pre-politica, all’egemonia culturale e al dominio materiale delle nuove tecnologie digitali. Al netto, naturalmente, della fisiologica quota degli ingenui fiduciosi, dei collaborazionisti e dei mestatori sempre presenti in ogni momento della Storia.
L’emergenza sanitaria sembra invece offrire oggi un’occasione ghiottissima ai fautori della definitiva dematerializzazione dei processi di conoscenza. Le ragioni del distanziamento sociale imposte dalle condizioni di protezione della salute dei cittadini, che impattano su una scuola e una università pubbliche già devastate dal progressivo smantellamento capitalistico di decenni di politiche neoliberiste in tagli dissennati, disinvestimenti, mancate assunzioni, abbandono a sé stesse e alla loro miseria di gran parte delle istituzioni preposte all’istruzione e alla formazione, non sembrano lasciare scampo alla resa a una didattica a distanza divenuta, da emergenziale, ordinaria; da presente, a futura; da provvisoria, a definitiva.
Ne, magister, habeas corpus, ci dicono il Governo, la Ministra, la task force preposta alla ricostruzione della scuola a settembre, che se a parole e con tanta retorica all’ingrosso vagheggiano di scuola nei parchi, nei boschi, nelle biblioteche e nei musei, nei fatti investono 550 milioni di euro per la banda larga, dopo gli 85 milioni di euro di febbraio per l’acquisto urgente di tablet e pc, e ulteriori poche centinaia di milioni di euro con l’ultimo Decreto Rilancio solo per il potenziamento delle strutture per la didattica a distanza e l’adeguamento della strumentazione informatica. Un vero piano di investimenti sulla scuola prevederebbe ampliamenti strutturali e costruzione in tutta Italia di nuovi edifici scolastici ecosostenibili, con pannelli solari e fotovoltaici per la produzione di energia pulita, con aule ampie e palestre degne di questo nome, per gli studenti e per gli abitanti del quartiere. Un investimento culturale e materiale che davvero contribuirebbe a mettere in moto l’economia del nostro Paese, cui si prospettano anni terribili di recessione e disoccupazione senza precedenti.
Ma questo presuppone una concezione incorporata e creaturale della cultura, dell’istruzione e della formazione come occasione di crescita personale e volano di progresso umano e sociale prima ancora che economico; una concezione che al soluzionismo tecnologico (e tecnocratico) e alla ‘levigata’ data-crazia imperanti non interessa, anzi, se possibile, nuoce. Nella visione della task force che, insediatasi al MIUR, sta immaginando la scuola ibrida del futuro, anche la fisicità è considerata una piattaforma.
Dipende solo da noi insegnanti, a questo punto, capire che la vera posta in gioco col nostro corpo è il futuro stesso della scuola, dell’università, del Paese. E decidere che in aula, con i nostri studenti e per i nostri studenti, quel corpo, con tutto ciò che significa, lo pretendiamo ancora.
[1] https://www.roars.it/online/a-radio-popolare-il-progetto-di-scuola-ibrida-targata-azzolina/
[2] Rossella Latempa, Scuola e valutazione ai tempi del Covid, tra Fondazione Agnelli e Invalsi, ROARS, 30 marzo 2020
In che scuola vogliamo tornare? – Girolamo De Michele
In autunno, sul banco delle novità della biblioteca del liceo in cui insegno, c’era un libro adesso famosissimo, Spillover di David Quammen. L’ho tenuto in mano a lungo, sfogliandolo e leggiucchiandolo; l’amico bibliotecario mi ha chiesto se volevo prenderlo in prestito (mi conosce, e sa che di solito se tengo in mano un libro per un tot poi me lo porto a casa); ci ho pensato su, e poi gli ho risposto: magari in estate, adesso non ho il tempo di leggerlo. E poi, mi sono anche detto: una volta letto, dove trovo il modo di parlarne in classe, io che insegno storia e filosofia? Fatto è che il tempo di leggerlo (è un librone, anche se divulgativo), fra lezioni da preparare, compiti da correggere, e un mare di impegni burocratici da sbrigare, forse non lo avevano neanche le/i collegh@ di scienze.
Poi è arrivata la pandemia, il manifesto ha intervistato Quammen, e di colpo tutto il mondo dell’informazione ha “scoperto” Spillover: e a me è rimasto l’amaro in bocca per non averlo letto e non averne parlato, che sarebbe stato utile, eccome. Potrebbero obiettarmi: ma se l’aggiornamento è un obbligo, leggere un libro per farne argomento didattico non è ottemperare a un obbligo di servizio? La risposta è: no, non lo è. Se leggo un libro e imparo qualcosa, non è riconosciuto come aggiornamento. Se invece (com’è accaduto) c’è una “giornata di studio” nella quale la star dell’evento è una funzionaria del ministero la cui unica referenza è stata per anni l’aver co-firmato (ma col proprio cognome in piccolo) un libro assieme all’ex ministro Berlinguer – ma che, a dispetto di ciò, ha incarichi su incarichi: beh, quello sarebbe aggiornamento. Perché, un po’ come le banane, quel convegno aveva il bollino: quello della piattaforma SOFIA. Per la cronaca: non ci sono andato (e questo mi ha causato qualche problema). Ci fossi andato, avrei sentito magnificare un’idea di “insegnamento della filosofia nell’età della conoscenza” che riduce la disciplina a sola tecnica dell’argomentazione, attuando uno spezzettamento della complessità disciplinare in tanti segmenti omogenei suscettibili di valutazione quantitativa, prefigurato dalla proposta di istituzione di un “Sillabo di filosofa per competenze”: una filosofia, insomma, che cede davanti al proprio desiderio e si adatta a un ruolo di counseling filosofico.
Sono cose che avremmo dovuto rimeditare in altre sedi e in altri incontri. Poi è arrivato il coronavirus, a sovvertire le gerarchie di ciò che è o non è rilevante, importante, indispensabile – vitale, per troppe e troppi. E a porci un problema: in che tipo di scuola vogliamo tornare a insegnare? Che cosa vogliamo insegnare, a una generazione che ha patito il trauma della rottura del confine del corpo come illusorio scudo di sicurezza, che ha avuto l’esperienza della morte, esperita nei propri cari o prefigurata e temuta? Che, insomma, ha avuto una sorta di esperienza di una Alterità irriducibile al di là del pensabile – o quantomeno ne ha visto baluginare una luce oltre lo schermo? Potrei obiettare a me stesso: a parte la quotidiana tragicità della vita “ordinaria” – non hai avuto student@ che hanno attraversato la violenza domestica, conosciuto la guerra da quella Bosnia dalla quale sono fuggiti, lasciando lì i propri cari – quando non ne sono stati testimoni dell’assassinio, attraversato l’Africa e il Mediterraneo per arrivare fin da te? Ma, appunto: di questa ordinaria tragicità, ne facciamo scuola? La insegniamo? Ci poniamo il problema di costruire orizzonti di senso che ne tengano conto?
Nulla sarà come prima, è stato detto. Almeno in un senso è vero: a settembre torneremo a insegnare non davanti a testimoni della tragicità della condizione umana globale, ma davanti e dentro un’intera generazione: nessu@ esclus@. E questo, nessuno potrà modificarlo: il fiume nel quale ci bagneremo non sarà lo stesso fiume. O meglio: non potremo, anche volendo, illuderci che lo sia mai stato.
Quello pandemico è stato un evento; guardandolo dall’interno, anche se limitatamente all’indagine su quali possibilità per la scuola del domani, possiamo trovare segni di un potenziale contro-evento: a condizione di essere davvero convinti che quella “normalità” alla quale si vorrebbe ritornare era in realtà il problema al quale non si dovrà ritornare.
Il primo segno di una scuola possibile è una constatazione: sono stat@ le/gli insegnant@ a tenere in piedi e all’opera il sistema educativo. Non la burocrazia amministrativa, quella tempesta di adempimenti, regolamenti, carte fisiche e virtuali che a volte sembrano crescere fino al cielo, sottraendo tempo prezioso alla didattica – e che, incredibile a dirsi, nessun ministro o viceministro o sottosegretario o dirigente o commissario straordinario ha pensato di mitigare in ragione dell’emergenza; non i dirigenti, con buona pace della loro frangia estremista, vale a dire l’Associazione Nazionale dei Dirigenti Pubblici della Scuola (ANP), che si arroga questo merito, reclamando pieni poteri e mano libera; non il MIUR, apparso ai più come una navicella che mutava rotta a seconda del vento. Quelle e quegli insegnanti che si sono fatti carico della didattica a distanza (DaD) – raccogliendo elogi dalla comunità scolastica, e qualche commento fuori luogo da chi della scuola poco o nulla sa, ma ne parla comunque: come il popolo dei bar che, avendo tirato due calci al pallone qualche volta nella vita, si reputa in grado di dettare la formazione della nazionale. L’attività a distanza ha dimostrato tre cose fondamentali. In primo luogo, che le/i docenti sono in grado di autoaggiornarsi e di acquisire le “competenze digitali” (detto più terra terra: di sapere e di saper fare), senza bisogno di piattaforme SOFIA, corsi di aggiornamento farlocchi (e a pagamento). Com’è stato possibile? Con l’aiuto reciproco, il supportarsi l’un l’altro, il fare comune e comunità: a conferma che quella familiare non è né l’unica né la principale delle reti di socialità, solidarietà, supporto che si sono attivate nell’emergenza.
In secondo luogo, che la DaD, una volta messa in opera ed esperita, sta alla didattica reale, fatta di interazione, fisicità, emozioni, come i cinepanettoni stanno a Kubrick e Antonioni. Nel corso delle settimane di lockdown sono via via scemate, fino al silenzio, quelle voci che si erano levate inneggianti alla rivoluzione digitale: esperita e subita in concreto da docenti, studentesse e studenti, famiglie, si è rivelata, se posso rubare la battuta, una cagata pazzesca (ma davvero, in questo caso). Non è un caso che persino il Comitato Tecnico ha dovuto riconoscere che la DaD non può essere un’alternativa alla didattica in presenza: a difendere la DaD sono rimasti solo i dirigenti dell’ANP, non a caso persone che la DaD non l’hanno praticata.
In terzo luogo, che quello scolastico non è semplice trasmissione di informazioni – il sostrato culturale che accomunava le due controriforme di Gelmini e Renzi (l’antifrastica “Buona Scuola”), ma lavoro di cura. Lo scrivevo dieci anni fa nel mio La scuola è di tutti: la scuola è lo specchio di una società impazzita nella quale, come in una crema che non si è amalgamata, i singoli elementi galleggiano separati qua e là. Al tempo stesso, la scuola è un’istituzione del comune che si oppone a questa broda disgustosa: le è stato dato questo compito, e volente o nolente se ne deve fare carico, così come le comunità migranti si prendono cura dei nostri anziani e dei nostri campi e vigneti, così come le donne si prendono cura, garantendo la riproduzione sociale, di settori sempre più ampi di un contesto sociale attraversato da barriere e fratture.
Tutto questo deve, come un vortice, attirare gli elementi positivi della scuola di ieri, e rilanciarli in quella del futuro.
Ma la scuola non è una torre d’avorio isolata dal mondo nel quale esiste e col quale intrattiene relazioni. E quindi non è possibile parlare della scuola nell’emergenza pandemica senza chiedersi cos’è stata questa emergenza. Una crisi di carattere sanitario, in prima battuta; le cui cause vanno però cercate non solo internamente, con un approccio limitato alla medicina e alla biologia, e ai nuovi esperti immunologi e virologi (a loro volta in conflitto), la cui expertise è stata ben raffigurata da Donatella Di Cesare con la figura del timoniere di Agamennone, esperto nell’arte della navigazione, ma ignaro del destino di morte cui conduce il suo sovrano portandolo a casa attraverso i mari in tempesta. L’attuazione della zoonosi, che di per sé non è una novità, è incomprensibile senza la consapevolezza dei processi che portano ecosistemi fino a ieri distinti a mescolarsi; processi che coinvolgono le migrazioni di viventi tanto umani quanto non umani, e che si intersecano in un feedback perverso con gli effetti del mutamento climatico. Processi che a loro volta coinvolgono le modalità sia corporali che mentali di abitare la condizione umana nella quale siamo gettati: non è casuale che lo stigma di questa condizione sia un sintagma che è anche il titolo di un felice libro che apriva gli Anno Zero, L’epoca delle passioni tristi. Ed è emblematico che persino un dirigente scolastico regionale (quello dell’Emilia-Romagna), in una lettera alle studentesse e studenti in quarantena, lo abbia citato.
Questa semplice ricognizione pone una questione: quante discipline sono necessarie per comprendere questi processi? In altri termini, è plausibile che un sapere spezzettato in discipline divise da compartimenti stagni, all’interno dei quali ogni singola disciplina è ulteriormente suddivisa in “competenze”, “saperi minimi”, “parole-chiave”, mentre nuove gerarchie di saperi vengono prefigurate (ad esempio, in quel documento ministeriale che citavo in apertura) – è plausibile che un sapere così strutturato possa dar conto di una crisi che rimarrà come un orizzonte di possibilità per nuovi virus?
In tutta evidenza, no: non è pensabile che la scuola si chiami fuori da questo orizzonte, che si alieni da questa condizione umana che ci tocca abitare.
L’epistemologo Gregory Bateson chiamava questo sapere che connette invece di disperdersi e sfrangiarsi “ecologia della mente”: e già nel 1969 parlava di crisi nell’ecologia della mente. Il filosofo Félix Guattari, agli inizi dei Novanta, parlava della crisi ecologica come uno dei corni di una crisi molteplice: ecologica, sociale, psichica. E chiamava questo sapere che tenesse insieme i tre corni “ecosofia”. Lo storico bangladese Dipesh Chakrabarty chiama Antropocene l’epoca nella quale l’essere umano è diventato un fattore determinante del clima, e la studia con lo sguardo strabico di chi sa bene che se la crisi climatica ci chiama in causa come specie, al tempo stesso manifesta i suoi effetti secondo differenze e gerarchie di classe, genere, luogo: proprio come il coronavirus.
Quando mi viene chiesto che scuola vorrei, io penso che la fonderei su questi tre pensatori.
Ma c’è un altro nodo che il coronavirus, come un pettine, ha portato alla luce: una profonda crisi culturale e cognitiva, a tutti i livelli. Una crisi di cui sospettavamo l’esistenza, nella convinzione che l’evidenza mondo delle fake news, delle argomentazioni senza logica e senza costrutto, dei complottismi, fosse la punta di un iceberg del quale intuivamo la consistenza: quell’iceberg che Calvino (concludendo una discussione ventennale con Pasolini e Sciascia) aveva denominato “la peste del linguaggio”; una peste che «colpisce la vita delle persone e la storia delle nazioni, rende tutte le storie informi, casuali, senza principio né fine». Un iceberg che Tullio De Mauro aveva cercato di descrivere attraverso la prima rilevazione degli apprendimenti, negli Anni Zero, sottolineando che «soltanto il 20% della popolazione adulta italiana possiede gli strumenti minimi indispensabili di lettura, scrittura e calcolo necessari per orientarsi in una società contemporanea», mentre per la restante parte, a diversi livelli di analfabetismo funzionale, «un testo scritto che riguardi fatti collettivi, di rilievo anche nella vita quotidiana, è oltre la portata delle loro capacità di lettura e scrittura, un grafico con qualche percentuale è un’icona incomprensibile».
E chiedendo a gran voce, invano, che ogni fondata riflessione sulla scuola e sul fare scuola partisse da qui. La crisi ha mostrato quanto grave sia questo diffuso analfabetismo funzionale. L’incapacità di costruire, leggere, interpretare una statistica; di saper connettere i dati; di saper leggere una comunicazione scientifica in lingua inglese senza l’ausilio di maldestri traduttori on line; la capacità di connettere causa ed effetto, di costruire un’affermazione sensata a partire da due premesse ben fondate: tutto questo si è mostrato in tutta la sua gravità non nel mondo social dove tutto vale tutto, ma anche nelle testate giornalistiche di livello: i peggiori negazionismi, complottismi hanno potuto sguazzare in queste pozzanghere. Un bravo divulgatore scientifico come Piero Angela appare, a fronte di quello che è stato narrato a partire da malcomprese pubblicazioni mediche e scientifiche, un gigante. In molti hanno scoperto che, per contro, bravi ricercatori dai loro spazi social, con tabelle e grafici interpretati in autonomia, erano più attendibili di quelli presenti sulla stampa mainstream. Al tempo stesso, abbiamo toccato con mano come l’immagine dello scienziato sia percepita dall’opinione pubblica in termini ante-galileiani e newtoniani: al conflitto delle facoltà fra biologi, immunologi e virologi si è aggiunto quello generato dal consenso della pubblica opinione verso guru sedicenti esperti, persino in ambienti che si credevano temprati dal pensiero critico. Il punto più basso è stato toccato, sperando che sia davvero il fondo, quando un redivivo don Ferrante è comparso ad annunciare che l’epidemia era inventata, ovvero esistente ma esagerata, con evidenze prodotte taroccando i numeri e ritagliando col metodo dei morceaux choisis parole altrui: è stato creduto, difeso, assunto a vate da una parte, per fortuna piccola ma significativa, della pubblica opinione, ma anche delle istituzioni filosofiche, a riprova che resta ancora grande «l’autorità di un dotto, quando vuol dimostrare agli altri le cose di cui sono già persuasi». E che la peste del linguaggio ha avvelenato pozzi e falde in profondità.
È da tutto questo che la scuola deve ripartire. Nella consapevolezza che ogni istituzione scolastica è presa fra due contemporanee esigenze e funzioni: assoggettare le/i discenti al sapere esistente, incatenando il presente al passato; o favorire la formazione di soggetti liberi, perché autonomi e creativi rispetto all’esistente, proiettando le soggettività verso il futuro. È in questa compresenza fra assoggettamento e processi di soggettivazione, che la scuola svolge la sua funzione: chiedersi qual è la scuola del futuro significa fare una scelta di campo fra i due poli di questa ellisse.
La scuola che verrà, dunque. Le politiche scolastiche dell’ultimo ventennio hanno consapevolmente guidato la scuola verso scenari che oscillano fra la conservazione che apre alle dinamiche di mercato, e la privatizzazione di ampi settori dell’educazione attraverso la dismissione e l’esternalizzazione verso il privato, o l’ingresso del privato nel pubblico. Per contrastare questa deriva, che appare trasversale fra le diverse coloriture delle forze politiche e le divers@ persone che hanno ricoperto il ruolo di ministro dell’istruzione, occorre essere consapevoli della direzione verso cui si vuole guidare la nave della scuola, per orientarne le vele. La direzione delle politiche di conservazione o di descolarizzazione va invertita verso uno scenario di riscolarizzazione, centrato sul riconoscimento dell’educazione come bene del comune, e sulla ricerca di alti livelli di motivazione (anche salariale) del corpo docente con massicci investimenti pubblici, e politiche che incentivano la fiducia nell’istruzione pubblica. La scuola deve tornare al centro delle attività comunitarie o di una pluralità di istituzioni educanti, all’interno di un processo di formazione permanente governato da politiche che favoriscono la coesione sociale e contrastano la formazione delle disuguaglianze, attraverso un reciproco scambio di processi formativi ed educativi fra scuola e società.
Al centro della scuola del futuro, che è una scuola che comincia già oggi, c’è tanto la sua funzione, quanto la sfida della complessità e della globalizzazione. Si tratta di chiedersi quale sapere, in quali forme strutturato, attraverso quale scaffalatura del sistema educativo organizzato, possa fornire i requisiti minimi, sia in termini di sapere che di saper fare, sia di contenuti che di capacità (mi si perdoni il lessico antiquato con cui sostituisco la terminologia à la page fra i nemici della scuola). La riforma della scuola media unica, all’inizio degli anni Sessanta, era fondata sul presupposto che, in quel tipo di società, la licenza media garantisse a tutt@ il sapere necessario per orientarsi in un mondo tutto sommato lento e locale. Si tratta di essere all’altezza di quella scommessa, e chiedersi oggi quale è il livello di sapere minimo necessario per orientarsi nella globalizzazione e nelle sue crisi sistemiche, e quali saperi specifici – ad esempio, logica e semiotica, di fatto assenti dai curricoli scolastici, se non per spizzichi e bocconi – possano fungere da raccordo fra le diverse aree e i diversi sitemi di apprendimento, dentro e fuori la scuola.
È inutile negarcelo: il prossimo anno sarà un anno di crisi, indipendentemente dalla riproposizione della pandemia. Una crisi che può essere bypassata, limitandosi a registrare il lascito di quest’anno in ulteriori moduli, piani, carte – il Piano Integrativo degli Apprendimenti, e il Piano di Apprendimento Individualizzato, il PIA e il PAI, che come le due gemelline di Shining appaiono davanti alle/ai docenti tenuti a compilarli prima ancora di sapere dove, come, quando faranno scuola il prossimo anno. Oppure cogliendo nella necessaria emergenzialità l’occasione per cominciare a ridisegnare il sistema di istruzione, a partire dalle esigenze che la crisi ha portato alla luce, e pretendendo che fondi, organici, istituti siano adeguati alle esigenze educative, piuttosto che adeguare queste nelle scarpe troppo strette delle risorse octroyées. Dopo tutto dovremo pur parlare di quel che è accaduto a studentesse e studenti di ritorno dalla quarantena.
L’emergenzialità permanente ha già mostrato il suo aspetto giuridico-legislativo, sotto forma di decreti e norme che di fatto hanno derogato e derogano dall’esistente: prendiamone atto, e chiediamo che questi stessi strumenti vengano utilizzati per più alte finalità. Ad esempio, restituendo collegialità al governo della scuola, ripristinando quelle istituzioni abrogate da Berlinguer, Moratti, Gelmini, Renzi. Ad esempio, sovvertendo l’attuale definizione degli organici e riportando in vita la promessa mai realizzata degli organici funzionali. Ad esempio, dando alle istituzioni collegiali – a partire dai collegi docenti – il potere costituente di riunirsi in assemblea per redigere dei Quaderni di lagnanze che dal basso porti alla elezione di Stati Generali dell’istruzione e della Conoscenza con potere costituente di ridisegnare l’edificio abitato dalla comunità educante, con porte aperte in entrata e in uscita verso la società – non verso i rapaci avvoltoi di Confindustria, ma in relazione con le mille forme di socialità e solidarietà che si sono manifestate in questa emergenza.
Non è un programma ministeriale: se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare, recita uno dei miei breviari. È il programma della scuola che riparte, che vuole ripartire: ripartire le ricchezze privatizzate, gli edifici sfitti, il denaro accumulato con lo sfruttamento del lavoro e dei lavoratori. Ripartire gli spazi vuoti per ampliare quelli scolastici, ripartire le destinazioni dei terreni edificabili per ripartire le comunità scolastiche in nuove scuole, più grandi e più belle, perché oltre al pane e ai devices vogliamo anche le rose, vogliamo il diritto a tutte le cose belle; ripartire il potere gestionale dei dirigenti scolastici e dei servizi amministrativi nella collegialità del comune; ripartire i ruoli sociali definiti dalla rigidità sociale abbattendo pareti e soffitti di vetro, ma anche sciogliendo la colla che fissa le scarpe ai pavimenti, perché il mondo che verrà sia davvero una terra delle pari opportunità; ripartire i piani dell’ascensore sociale nell’orizzontalità di una costruzione senza piani; ripartire le ricchezze dell’1% nel 99%.
Ripartire, per davvero.
Colao e la Scuola: slogan e numeri al retrogusto di supercazzola – Anna Angelucci, Renata Puleo
“Non sprechiamo una crisi” – una frase che ormai suona come un mantra – sottolinea e sottoscrive la task force di economisti guidata da Vittorio Colao per rilanciare il Paese dopo l’emergenza Covid. Ma per carità, e chi vorrebbe sprecarla questa crisi! Finita la conta dei morti che non abbiamo neanche potuto seppellire, una conta tanto dolorosa quanto in larga parte dolosa, ci resterebbe una preziosa occasione per individuare e correggere tutte le storture di un sistema che, a livello politico, economico, sanitario e sociale, questa crisi l’ha prodotta e aggravata. Nelle more di una riflessione politica lenta a venire, come sempre accade quando si deve fare molta autocritica e grande assunzione di responsabilità, sgombriamo il campo, se possibile, da mistificazioni e supercazzole.
Il Piano Colao ha l’ambizioso obiettivo “di accelerare lo sviluppo del Paese e di migliorare la sua sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con gli obiettivi strategici definiti dall’Unione europea” nella sua roadmap for recovery. Non poteva certo mancare una sezione dedicata a istruzione e ricerca, da tutti considerate – a parole – fondamentale volano di crescita ma – nei fatti – sistematicamente marginalizzate.
Proviamo a leggere il lavoro di Vittorio Colao e della sua task force, le cui parole d’ordine sono capitale economico, capitale umano, capitale sociale e capitale naturale, ovvero il patrimonio e il profitto, come ci ricorda Thomas Piketty, ottenuti con l’immissione nella catena del valore e lo sfruttamento anche di educazione e istruzione. I paragrafi 75-87, ad essa riservati, sono interamente declinati all’insegna delle parole d’ordine del neoliberismo più sfrenato e sfrontato: modernizzazione, innovazione, semplificazione, flessibilità, competizione. Mai, neanche una sola volta, compare la parola ‘cultura’.
Per quanto riguarda la scuola, il problema principale è legato alle profonde differenze di qualità fra livelli di istruzione, percorsi formativi e aree territoriali. Già a 15 anni i nostri studenti mostrano livelli di apprendimento sistematicamente inferiori a quelli della media dei Paesi OCSE
esordisce Colao parlando di scuola.
Non è esattamente così. Se andiamo sul sito dell’Invalsi e leggiamo la sintesi dei risultati del rapporto OCSE PISA 2018 troviamo scritto che (l’evidenziazione in rosso è nostra):
Gli studenti italiani ottengono un punteggio di 476, inferiore alla media OCSE (487) [pag. 3]
[…]
l’Italia presenta una percentuale di studenti che raggiunge almeno il livello minimo di competenza in lettura analoga alla percentuale media internazionale. [pag. 6]
In matematica gli studenti hanno ottenuto un punteggio medio nelle prove PISA in linea con la media dei paesi OCSE (Italia 487 vs OCSE 489). [pag. 10]
[…]
I risultati in matematica sono migliorati nel 2009 per poi rimanere stabili nel tempo. [pag. 11]
Gli studenti italiani hanno ottenuto un punteggio medio nelle prove PISA di scienze al di sotto della media dei paesi OCSE (Italia 468 vs OCSE 489). [pag. 10]
[…]
In scienze, i trend dei risultati nei paesi OCSE indicano una parabola negativa: al lento miglioramento osservato fino al 2012 ha fatto seguito un calo nel periodo 2012-18 e nel 2018 la performance media dei paesi OCSE è tornata al valore rilevato nel 2006. L’andamento dei risultati in scienze per l’Italia è in linea con il dato internazionale. [pag. 11]
Dunque non è poi così chiaro che, come afferma Colao, i livelli di apprendimento dei nostri studenti sono “sistematicamente inferiori a quelli della media dei Paesi OCSE”.
E’ invece innegabile, come scrive il Rapporto, che ci sono forti sperequazioni territoriali e culturali tra Nord, Sud, Centro e Isole, insieme a fortissime disparità nella qualità del rendimento degli studenti tra i diversi ordini di scuola, con gran parte dei tecnici e dei professionali sistematicamente in declino. E’ sotto i nostri occhi, non ci sarebbe alcun bisogno di test campionari o censuari per fotografare l’esistente.
Ma i Colao di oggi, e i Gavosto di sempre, per sopperire alle carenze formative di un sistema che l’autonomia scolastica ha disgraziatamente legato al territorio in un determinismo tutt’altro che emancipante (quell’autonomia ormai ventennale che è andata cronologicamente di pari passo con l’aumento delle sperequazioni formative) e i cui obiettivi culturali e educativi sono stati lentamente cancellati dalla vuota ideologia delle competenze, propongono la “progettazione di iniziative di upskilling (co-finanziate da pubblico e privato), facendo leva sul settore privato per supportare in partnership insegnanti, cultura, ricerca e scuola” lanciando “una campagna di volontariato che affianchi le strutture pubbliche (ovviamente senza sostituirle) nel supporto della formazione, sia “cash” (in contanti, NdR) che “in kind” (in natura, NdR), articolata in tre proposte:
1) “Adotta una classe”, ovvero l’organizzazione di una campagna di crowdfunding e donazioni per il potenziamento delle strutture “educational”, con la quale infrastrutturare digitalmente e tecnologicamente classi di diverso ordine e grado (sic!) in modo da contribuire a creare un sistema “equal opportunity” nell’istruzione (ad es. dotare di streaming , PC e supporti informatici le classi per didattica a distanza), attraverso una contribuzione “cash”.
2) “Impara dai migliori”: ovvero un programma nazionale coordinato di “aggiornamento degli educatori” per il quale 20 sabati all’anno grandi aziende high tech, enti di ricerca e università fanno corsi di aggiornamento su temi innovativi agli insegnanti di liceo e medie. Le lezioni possono essere frontali o a distanza. I contenuti vanno sincronizzati e resi omogenei a livello nazionale. L’iniziativa è gratuita. La formazione va riconosciuta dal MUR . La contribuzione è “in kind”.
3) “Gara dei talenti”: aziende e donatori organizzano una serie di concorsi tipo Hackathon per giovani studiosi (scuole superiori) su temi di grande rilievo tecnologico, sociale e culturale. I concorsi premiano gli studenti e le scuole (e casomai li mettono in contatto con investitori). La contribuzione è “cash/in kind”.
Accanto alla campagna di volontariato e accattonaggio, Colao e i suoi propongono la pianificazione di un accordo con RAI Scuola/RAI Educational per il potenziamento di forme di didattica innovative, con le dosi massicce di pubblicità che, come abbiamo visto, accompagnano questi programmi (il modello, irraggiungibile, è sempre l’America, dove accordi tra aziende e scuole prevedono per i malcapitati studenti il trangugiamento di interi quarti d’ora di pubblicità direttamente dai grandi schermi in classe tra una lezione e l’altra). Innovativo è, infatti la parola magica che, da anni, preme ai confini del nostro lessico educativo. E adesso certo, come si fa a sprecare una crisi, visto che l’emergenza sanitaria ha accelerato la spinta radicale delle multinazionali high tech alla digitalizzazione del mondo? Piattaforme digitali, device, webinar, conference call, streaming, didattica blended: tutto questo non può essere archiviato nel perimetro della straordinarietà ma deve, al contrario, diventare la nuova normalità della scuola. Dopo la ‘buona scuola’ di Renzi, la neo-scuola di Colao: educational, smart, cash, in kind, charter, upskilled, adopted.
Ma è ora di dire basta alla “tarapía tapióco come se fosse antani”.
Quanto questo modello – anche nella sua miopia – rappresenti soprattutto un attacco alla scuola di base dovrebbe essere inteso da tutti. L’equiparazione degli istituti comprensivi ad una azienda dell’obbligo a guida pseudo-manageriale, il depotenziamento del tempo-scuola, il taglio degli organici, la scarsa o nulla attenzione ai figli degli immigrati, ai figli dei proletari (esistono, ahimè pur se a qualcuno piace pensare che non esistano più le classi), alle bambini e ai bambini diversi, ha soffocato le migliori esperienze educative e didattiche espresse nel secolo scorso. Perché, se la scuola ha bisogno di cambiare paradigma – ma dobbiamo intenderci su quale – lo deve fare a partire da una buona tradizione che, prima di esser tradotta/tradita, andrebbe conosciuta. Magari anche insegnata nei molti corsi di laurea di Scienze della Formazione.
La cultura è relazione oppure non è – Franco Lorenzoni
Tutto parte dalla dignità, dalla dignità che riusciamo a dare ai nostri allievi. Il primo compito di noi insegnanti sta nel riconoscere il diritto a una piena presenza e cittadinanza a tutte le bambine e i bambini nella vita della classe. E il primo modo per dare spazio e consistenza ai loro diversi modi di abitare e vivere la scuola sta nella nostra capacità di ascolto. Ma un ascolto ascolto attento e partecipe nasce e vive solo se siamo profondamente convinti che bambine e bambini, ragazze e ragazzi pensino, creino e operino connessioni, se consideriamo che tutte le loro ipotesi, anche fantastiche, siano strumenti epistemici, modalità per conoscere il mondo.
Occorre dunque riconoscere e convincerci che i bambini non solo hanno desiderio di dire la loro, ma a ogni età ragionano, formulano ipotesi, usano una logica che talvolta può apparire diversa da quella di noi adulti, ma che ha sempre al suo interno una coerenza e una profonda tensione conoscitiva che vanno riconosciute e a cui dobbiamo restituire valore in tutti i modi possibili.
Bambini e ragazzi, infatti, pensano e molte volte pensano con particolare profondità e acutezza, ma spesso i più non hanno cognizione della qualità dei loro pensieri, se questi non vengono raccolti e restituiti da parte di noi adulti. Si tratta allora di riconoscere ciascuno di loro come soggetto i cui gesti e parole sono accolti con cura e attenzione. Si tratta di costruire un contesto adeguato all’incontro di modi di guardare il mondo e di porsi diversi, mettendo l’ascolto reciproco e la conversazione al centro della pratica educativa.
Dentro questo paesaggio, che possiamo definire di pedagogia dell’ascolto, nasce e vive il dialogo euristico. La scintilla del dialogo si accende quando il lavorio mentale dei bambini si scontra ed entra in connessione con i diversi oggetti culturali portati dall’insegnante o in cui ci si imbatte nel corso di esperienze o discussioni che suscitano interrogativi non necessariamente previsti. Quando le loro conoscenze più o meno codificate incontrano nuovi contesti e contenuti portati da noi adulti, dall’ambiente o dai loro compagni. Solo se l’insegnante non guarda con sospetto e non si lascia spaventare dall’apparente confusione del libero pensare di bambini e ragazzi, si creano le condizioni per scoprire insieme qualcosa di nuovo «sfregando e limando i nostri cervelli gli uni contro gli altri», come suggeriva di fare Montaigne.
L’agricoltura chimica cerca il massimo rendimento sopprimendo tutto ciò che può danneggiare la crescita del frutto atteso. Sappiamo che questa semplificazione forzata avvelena il terreno, le acque e spesso produce frutti che pagano l’apparente bellezza, l’omogeneità e la grandezza con un minor sapore. Ecco, la scuola deve rifuggire le semplificazioni, le accelerazioni e le scorciatoie, affrontando un faticoso processo che somiglia maggiormente all’agricoltura biologica, nella quale si cerca di preservare ogni elemento naturale nella sua diversità. Tutto ciò necessita di un tempo più lungo e comporta maggiore attenzione e fatica, ma non depaupera il terreno, non inquina le acque e dà la possibilità di gustare sapori diversi e più autentici.
Quando riusciamo a creare le condizioni perché si realizzi una conversazione capace di ascolto reciproco, i diversi pensieri hanno la possibilità di venire alla luce e la molteplicità degli approcci diventa territorio di crescita del gruppo, di ciascun bambino o ragazzo, e naturalmente anche di noi che insegniamo.
Solo se abbiamo la capacità di sostare a lungo attorno a un contenuto culturale, dandoci il tempo di moltiplicare le domande, possiamo scavare e scoprire i tanti particolari e dettagli che si nascondono in un testo, in una pittura o in un teorema. In quello scavo, se lo compiamo in gruppo in una classe abituata all’ascolto reciproco, abbiamo la possibilità di scoprire, al tempo stesso, peculiarità e caratteri di ciascuno di noi. Ecco allora che l’oggetto culturale ha la possibilità di mostrarsi con un grado maggiore di verità perché illuminato da tante diverse interpretazioni personali, che poco a poco potranno emergere confrontando i nostri pensieri. Se guardo un affresco di Giotto con quarantaquattro occhi invece che con due, forse scoprirò qualcosa di più perché quei diversi sguardi, se riusciranno a tradursi in parole, mi mostreranno ciò che non avevo visto. Allo stesso tempo Giotto mi aiuterà a scoprire qualcosa di più delle bambine e dei bambini che mi accompagnano in questa avventura, mettendo in luce alcuni loro procedimenti mentali. Ecco che, in questo viaggio di andata e ritorno, la conoscenza dell’oggetto si delinea meglio, si affina, e forse si moltiplica.
La mia alunna Marianna, in quinta elementare, ha spiegato in modo esemplare questo processo, al termine di un lungo lavoro intorno all’affresco della Scuoladi Atene, affermando: “Raffaello ha fatto veri i filosofi per metà, noi per l’altra metà”. Ci sono due espressioni di questa frase particolarmente pregnanti: Marianna evoca il noi, perché si tratta della costruzione di una conoscenza collettiva, e indica nell’averli “fatti veri” quel necessario processo di avvicinamento alla “verità” dell’oggetto che comporta un fare tutto nostro, che ci riguarda perché richiama la nostra responsabilità. Raffaello, con la sua arte mirabile, può fare solo la metà del lavoro. Se noi non compiamo l’altra metà quell’affresco rimarrà inerte, inutile, morto. Dunque la cultura è relazione, solo relazione, o non è.
Nel dialogo euristico ci scambiamo liberamente le tante versioni, visioni e interpretazioni portate da ciascuno, assaporando la bellezza dell’accorgerci che ogni risposta è parziale e può sempre arricchirsi dello sguardo di un altro e arricchirci di nuove domande.
Questo aspetto rende particolarmente attuale e necessario il dialogo come architrave del processo educativo, perché in un tempo in cui prevalgono affermazioni non dimostrate e semplificazioni disarmanti, basate su reazioni istintive, la fatica del comporre e scomporre pensieri, cioè l’arte del ragionare tenendo conto dei punti di vista e delle ragioni degli altri, ci pare qualità e competenza che è necessario sviluppare e affinare nei bambini, nei ragazzi e in ciascuno di noi.
Forse è vero ciò che affermava nel 1721 Jonathan Swift, quando scriveva che «Il ragionare non farà mai correggere a un uomo un’opinione sbagliata che non ha acquisito ragionando». Ma noi, nella scuola, non possiamo non provare a dare, chiedere e chiederci ragione di ogni cosa. E il modo migliore di affrontare questa sfida culturale sta nell’avere pazienza e darci tempo per farlo insieme, dando voce e ascoltando tutte e tutti.
Quando la scuola diventò una videosceneggiata – Amedeo Spagnuolo
Di buon’ora, nella luce dorata del mattino, Stuart McConchie spazzava il marciapiede davanti alla Modern Tv Vendita e Riparazioni; sentiva il viavai delle auto lungo Shattuck Avenue, i tacchi alti delle segretarie che si affrettavano verso gli uffici, tutto il fermento e gli odori pungenti di una nuova settimana, un’altra settimana in cui un buon commesso poteva mandare in porto un mucchio di cose.
Così comincia Cronache del dopobomba uno dei libri, secondo il mio punto di vista, più belli di Philip K. Dick lo scrittore americano che ha prodotto dei veri e propri capolavori facendo oscillare la sua materia creativa tra fantascienza e filosofia. Sono andato a riguardarmi questo incipit, quintessenza di una vita “normale” che però nasconde e prepara un mondo che di normale ha ben poco, dopo una delle mie grottesche videolezioni di storia. Ho sentito il bisogno di fare ciò perché mi è sembrato, per un attimo, di rivivere durante quella lezione, ovviamente senza esagerare troppo e con le dovute differenze, le atmosfere di un mondo che si sforza tenacemente di essere normale ma che di normale, almeno per il momento non ha più nulla. Una delle cose che mi colpisce maggiormente, durante queste lezioni, riguarda il fatto che su queste piattaforme digitali, almeno quella che stiamo usando noi funziona così, non è possibile osservare i volti e le espressioni di tutti gli alunni, ma al massimo di 9 discenti, tutti gli altri diventano dei minuscoli cerchietti dentro i quali sono indicate solo le iniziali dei loro nomi, Karl Marx parlava di alienazione, questa come la vogliamo definire? Nell’angusta dimensione della didattica a distanza tutto diventa più difficile, molti potrebbero pensare che gli alunni dovrebbero sentirsi più tranquilli e distesi, e invece no, molti di loro confessano che molto spesso gli accade di bloccarsi di fronte al monitor, è come se quella barriera digitale non consentisse una fluida comunicazione tra docente e discente. Non bisogna essere degli esperti per capire che per imparare in maniera non nozionistica, la relazione empatica tra docente e alunno è fondamentale, lo schermo, invece, si frappone tra le due entità, quella docente e quella discente, non consentendo la creazione di quel clima caldo, avvolgente e avventuroso che la maggior parte delle volte si crea all’interno delle nostre scalcinate aule scolastiche. Lo stesso concetto, espresso ovviamente con una qualità e una passione uniche, era già stato spiegato dal collega – scrittore Marco Lodoli che in un fantastico articolo pubblicato su Repubblica nel 2001 aveva scritto:
“Dal 1981 passo tutte le mie mattine tra la cattedra e i banchi, cercando di insegnare qualcosa di italiano e di storia, e intanto discutendo con gli alunni intorno a tutti i temi importanti dell’esistenza. Devo dire che per me lavoro più emozionante non esiste. Ho collaborato a programmi radiofonici, a case editrici, a riviste e giornali, ho scritto romanzi e articoli, testi teatrali e sceneggiature, ma nulla mi ha dato le stesse emozioni, nulla mi è parso mai così decisivo come le ore che continuo a trascorrere insieme a quegli adolescenti, in classi mal riscaldate, tra pareti spesso imbrattate da frasi d’amore e d’odio. E’ come stare in mezzo al mare su una barca che scricchiola: e a volte c’è una bonaccia preoccupante, a volte onde fragorose, non si può mai sapere in anticipo cosa accadrà, ma è comunque un viaggio di cui il comandante è responsabile”. E Lodoli, per sua fortuna, non aveva dovuto vivere la frustrante esperienza della Didattica a distanza. Egli coglie, secondo me, l’essenza dell’insegnamento: quando entriamo in classe, il nostro compito principale non è quello di compilare registri elettronici sempre più complessi, leggere circolari e smanettare per ore con il computer e poi, se rimane un po’ di tempo, scambio quattro chiacchiere con i miei alunni. Il nostro compito è quello indicato magistralmente da Lodoli nel suo articolo. Con i nostri alunni, all’inizio dell’anno scolastico, cominciamo un viaggio, una vera e propria avventura perché non sappiamo dove i nostri discorsi ci porteranno, noi docenti non sappiamo ancora bene chi abbiamo di fronte e lo stesso vale per i discenti, però solo rischiando insieme, insegnanti, alunni e famiglie, possiamo sperare di concludere questa avventura nel migliore dei modi ovvero non accontentandosi di trasmettere ai nostri alunni poche nozioni rimasticate, ma cercare di far scoprire loro la bellezza di una vita vissuta inseguendo una passione che potrà tradursi in un vero e proprio lavoro ma che potrebbe anche soltanto, e non è poco, aiutarci a vivere svolgendo un lavoro che odiamo o spingerci a cercarne un altro senza lasciarsi andare alla depressione, grazie alla forza della passione che ci spinge ad andare avanti. Tutto questo è stato spazzato via, almeno per ora, dagli iniziali entusiasmi creatisi intorno alla didattica a distanza che i tanti guru dell’ideologia aziendalista, almeno nella prima fase del lockdown, hanno addirittura individuato come il futuro dell’istruzione, insomma come l’inizio della fine del ruolo dell’insegnante. Qualcuno si è addirittura spinto a dire che arriverà il giorno in cui grazie all’evoluzione dell’intelligenza artificiale, dietro quei monitor non ci saranno più docenti, non ci saranno più persone in carne e ossa con emozioni e sentimenti da condividere con gli alunni ma software quasi perfetti che riusciranno in brevissimo tempo a formare l’intelligenza cognitiva dei nostri ragazzi, in cambio però di un prezzo altissimo ovvero lo svuotamento di tutte quelle altre forme d’intelligenza, emotiva, artistica ecc. che ormai abbiamo imparato a conoscere dai tempi di Howard Gardner, lo psicologo statunitense che ha fondato la teoria dell’intelligenza multipla. Dopo i primi ardori però è arrivata la sana esperienza empirica a spegnere, almeno per il momento, gli entusiasmi della prima ora, non solo da un punto di vista scientifico, ma soprattutto da un punto di vista sociale cioè quando ci si è resi conto che questo tipo di didattica a distanza, se applicata sistematicamente, avrebbe portato, inevitabilmente, a nuove forme di povertà culturale e amplificato il fenomeno dell’abbandono scolastico. Per comprendere meglio ciò che ci stava o, mi auguro di no, ci sta accadendo mi affido ancora alle illuminanti parole del geniale Philip K. Dick: Lo strumento fondamentale per la manipolazione della realtà è la manipolazione delle parole. Se puoi controllare il significato delle parole, puoi controllare le persone che devono usare le parole.
MaLEducatrici? – Lettera di una lavoratrice bolognese nell’ambito dell’educazione
Già poco dopo la chiusura delle scuole in Emilia Romagna abbiamo denunciato il trattamento scorretto che si stava tenendo nei confronti di educatrici ed educatori. Pubblichiamo a questo proposito il contributo di un’educatrice sugli sviluppi della vicenda e lasciamo alla chiusura del testo alcune nostre considerazioni.
A settembre sono stata finalmente assunta come educatrice scolastica, dopo anni e anni di lavori come barista, cameriera, paninara dei concerti, vendemmiatrice, babysitter e chi più ne ha più ne metta. Dopo anni di precarietà assoluta riesco a prendere una maledetta laurea triennale in Scienze dell’educazione. A settembre come hanno fatto in tant* mando il mio CV alle cooperative sociali della zona e in un attimo sono assunta. Contratto part-time tempo determinato 18 ore alla settimana. Non ho interventi educativi assegnati, sono una delle tante jolly disponibili dalle 7:30 della mattina alle 18:00 su tutto il territorio bolognese. I miei orari e luoghi di lavoro mi vengono comunicati la sera prima o la mattina stessa, a seconda delle assenze che vado a sostituire. Capisco da subito che non sarà facile e che tante cose non mi tornano: come mai non sono inquadrata come lavoratrice di livello D2 nonostante io abbia il titolo per esserlo? Come è possibile che io arrivi a fare 47 ore settimanali se ho contratto di 18? E come è possibile che in altre settimane invece si dimentichino di me e lavoro 5 ore? E’ il lavoro in cooperativa baby, è l’esternalizzazione dei servizi del welfare, sei una delle tante pedine del mondo degli appalti, né la prima né l’ultima.
Nonostante mi renda ben presto conto che son stata ingenua a ritenermi finalmente fuori dal girone della precarietà vado avanti con il mio lavoro. E vivo in un limbo di emozioni. Da una parte la gioia di lavorare con bambin* e ragazz* che mi dà una carica immensa, mi riempie di curiosità e di voglia di fare. Dall’altra lo scoprire ogni giorno le contraddizioni intestine del mondo della scuola, la svalutazione del ruolo degli educatori ma anche degli insegnanti precari me la fa scendere tutta e mi fa incazzare. I mesi passano e finalmente mi vengono assegnati degli interventi educativi. Raggiungo un monte ore settimanale di circa 35 ore. Insomma le cose si stabilizzano un minimo per me e mi si dice di ritenermi fortunata per non essere più un jolly ancora per due o tre anni.
Qualche settimana e la scuola chiude. Mentre il Coronavirus si diffonde e insieme a lui si inasprisce il distanziamento sociale, mi chiedo che ne sarà del nostro lavoro, delle persone con cui lavoriamo e dei nostri stipendi. Si comincia a parlare di didattica online e io sono perplessa. Ma come pensano di fare con persone che hanno patologie gravi? E con quelli che non hanno i mezzi necessari? Del resto anche io non ne ho, a proposito. Ho tanti dubbi, la cooperativa per cui lavoro non manda comunicazioni che me li chiariscano, e spesso e volentieri le coordinatrici disertano le telefonate. Grande silenzio, la chiusura delle scuole è evidentemente prolungata e dei nostri salari nessuno parla. Poi eccolo lì, l’ultimo definitivo affondo alla mia ingenuità: per noi educatrici si ricorrerà al FIS. Il famigerato FIS, l’ammortizzatore sociale che tutti gli educatori scolastici con contratto a tempo indeterminato conoscono bene, perchè ogni estate si usa quello per non pagarli (e quelli a tempo determinato si attaccano, sperando di essere riassunti a settembre). Alcune colleghe ancora aspettano quello dell’estate scorsa. Ma perchè ci mettono in cassa integrazione, mi dico io, perchè? I soldi per pagarci tutto l’anno sono previsti nel bando di appalto e il Comune, pandemia a parte, li avrebbe comunque dovuti sganciare. E’ una questione burocratica, mi rispondono (i miei colleghi eh, la cooperativa ancora tace). Insomma questi soldi sono previsti ma non si possono erogare, perchè il servizio non è stato svolto, quindi sarebbe illegale da parte dell’ente pubblico. Sì ok, ma a quanto corrisponde questo FIS? Beh se vai a vedere quanto ti arriva alla fine, tra tassazioni, massimali possibili ecc si parla del 65% rispetto alla paga oraria standard, rispondono sempre le mie colleghe. Cominiciano a fumarmi le orecchie.
Successivamente ci viene richiesto di riorganizzare il nostro intervento educativo in modo da adeguarci alla situazione. E così riassegnano a ciascun* di noi delle ore, che dovrebbero esserci pagate al 100%, da svolgere in smartworking. Parte il delirio in chat: A te quante ne hanno assegnate? A me meno della metà di quelle che facevo. A me 5 su 30, a me il 60% ecc… A nessuna vengono assegnate tutte. Subito è chiaro che non c’è un criterio univoco, che per ogni Istituto Comprensivo e per ogni quartiere sono stati usati paramentri diversi, che questo lavoro è discriminante per chi non può svolgere l’intervento educativo a distanza, o per chi era impiegat* soprattutto nei servizi integrativi (pre e post scuola). Per non parlare delle colleghe jolly, a casa con il 65% del salario di un contratto da 18 ore.
Nel frattempo viene emanato il decreto Cura Italia. Nell’articolo 48 risulta che gli enti pubblici (tipo il Comune di Bologna) non sono obbligati ma comunque sono autorizzati a sbloccare i soldi di questo tipo di appalti, insomma vengono meno quelle scuse burocratiche di cui sopra. Evviva? No, perchè tutto rimane fermo. A parte pochissimi esempi sparuti, in tutta Italia l’art. 48 non viene applicato e viene ignorato.
A questo punto ricompaiono le cooperative e ci fanno sapere che per il mese di marzo anticiperanno loro l’ammontare del FIS. E di nuovo mi sento dire che ci dobbiamo considerare fortunate e che non è il caso di lamentarsi visto il panorama generale (e stavolta a parlare è la cooperativa). Se no i soldi chissà quando ci arrivavano.
Scopro che alcune colleghe che lavorano per la cooperativa Dolce sono nei guai. La cooperativa non anticipa nulla, invita però i suoi soci a richiedere “anticipi” agli istituti di credito associati fino all’importo di 700 euro al mese. A garanzia ci mettono il tuo TFR, così se l’INPS dovesse ritardare dopo 3 mesi possono prelevare direttamente da lì. In parole spicce, se vuoi dei soldi apriti un prestito in banca.Ti chiedono pure di pensare ai tuoi colleghi in difficoltà e devolvere loro le tue ferie. In fondo sei un socio, attingi al tuo spirito di socio.
E nei prossimi mesi come verremo pagati? Non è dato saperlo, si deve attendere che ai piani alti finiscano le loro partite a briscola sui nostri stipendi. Per fortuna alcune colleghe non ci stanno e protestano segnando sul monte ore del web tutte le ore che gli andrebbero riconosciute, le stesse di quando eravamo a scuola. In alcuni casi ricevono telefonate dalla cooperativa: ma sei sicura che hai fatto tutte quelle ore? e come le hai fatte? guarda che magari finisci nei guai… In altri casi le coordinatrici tagliano la testa al toro ed entrano direttamente sul web desk a modificare le ore dichiarate. Prendo fiato un attimo e mi chiedo cosa fare. Mi dico che tutto questo è assurdo e nel dirmelo mi rendo conto che lo era già ben prima del Coronavirus. Nel nostro e in tantissimi altri ambiti. Non ho nessuna intenzione di essere grata alla cooperativa perchè ci anticipa il FIS, né tanto meno agli enti pubblici perchè ci riconoscono un pugno di ore. Sono grata invece alle colleghe che prima di me hanno alzato la testa e hanno deciso di trovare modi per prendere parola sulle nostre vite, senza mai dimenticarsi delle persone con cui lavoriamo. Per questa e molte altre ragioni la strada ci chiama.
- La notizia di oggi è che la cooperativa per cui lavoro ha deciso di anticipare il 100% dello stipendio. Questa novità, per quanto positiva, non cambia la sostanza delle dinamiche intrinseche al lavoro in cooperativa, nè tanto meno cambia la situazione delle colleghe che lavorano per la Dolce o per tante altre cooperative ed enti in tutta Italia che stanno ricevendo buste paga ridicole, o addirittura vuote, quando non vengono spint* ad aprire prestiti in banca.
Leggendo questa testimonianza sorgono spontanee alcune considerazioni.
Innanzitutto, ovviamente, riteniamo che la richiesta sindacale di garantire il 100% degli stipendi alle educatrici e agli educatori sia legittima e, visto il livello di sfruttamento nelle cooperative, è già assurdo che la richiesta debba essere fatta. Questo però non deve impedirci di vedere a fondo il problema nella sua complessità.
Per prima cosa, il problema della frammentazione: i modelli di gestione del III settore negli ultimi 25 anni sono stati impostati su logiche di mercato, con un amplissimo spettro di regolazione del rapporto di lavoro. La situazione emergenziale ha solo reso evidente una condizione già altamente instabile. Ma è davvero funzionale un sistema che, per garantire l’assistenza a soggetti in difficoltà o in situazione di svantaggio, tratta in questa maniera proprio quei lavoratori e quelle lavoratrici che dovrebbero svolgere gli interventi di cura? Possiamo chiederci quanti danni ha creato questo sistema? Tanto a chi ne ha usufruito quanto a chi ha lavorato per esso? Quanto cioè questa totale instabilità ha reso più profonda l’emarginazione di tutti i soggetti coinvolti?
Nel testo, inoltre, si fa accenno all’idea che la singola persona debba indebitarsi con una banca innanzitutto per garantire il proprio stipendio e, in secondo luogo, l’elargizione del servizio. In pratica tutti i rischi ricadono sulle spalle di chi lavora. L’idea che più ti indebiti più in qualche modo hai speranza di farcela è assurda e quanto successo dal 2008 in avanti dovrebbe chiarirlo senza dubbio. Invece tanto le cooperative del territorio bolognese, quanto l’amministrazione comunale (col Sindaco in prima linea, come potete vedere dalla foto di copertina) continuano a sostenere questa modalità.
Questo avviene in un momento in cui la necessità del lavoro svolto da educatrici ed educatori è estrema. E tale rimarrà alla riapertura dell’attività scolastica dal momento che, se un’intera generazione sta vivendo una situazione di fortissimo disagio, le persone che già soffrivano una forte esclusione sociale sono ancora più colpite dagli avvenimenti di questo periodo. A questo punto ci chiediamo: come verrà gestito il ruolo dell’educat*, visto che il suo lavoro sarà ancora più decisivo di quanto è ora? Perché se la gestione futura si innesterà sui meccanismi che vediamo, il disastro sociale sarà ancora più devastante.
In più, se adottiamo una prospettiva che guarda all’educazione e alla formazione come un quadro unico, possiamo intuire una serie di ricadute anche su altri soggetti: se educatrici ed educatori non troveranno una situazione più stabile, tutto il lavoro che di solito svolgono, rischia di ricadere – nella migliore delle ipotesi – sulle spalle del corpo docente e delle famiglie, quando non sarà lasciato in balia del caso.

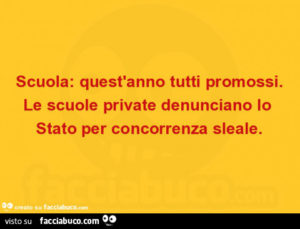

Io come madre di una bambina di 9 anni non porterò mia figlia a scuola per una che non ragiona quindi dico di dare le dimissioni a lucia azzolina